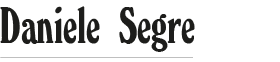Cineforum/ Tullio Masoni e Paolo Vecchi
La sinossi ufficiale di Morire di lavoro recita: « un film documentario che indaga la realtà del settore costruzioni in Italia, protagonisti i lavoratori e i familiari di lavoratori morti sul lavoro. La trama narrativa si sviluppa attraverso i racconti e le testimonianze dei protagonisti, ripresi in primo piano, che guardano in macchina. Altro elemento espressivo sono le voci di tre attori, due italiani e un senegalese, che interpretano ciascuno il ruolo di un lavoratore morto in cantiere…» La nota è esaustiva e basterebbe a introdurre l’intervista. Vogliamo comunque aggiungere un’osservazione. Segre definisce, col film odierno, la nuova tappa di un percorso che potrebbe prolungarsi per un tempo indefinibile. E’ il suo stile di lavoro; un modo che noi stessi, recentemente, abbiamo accostato a quello di Chris Marker:« Segre ha perseguito l’utopia del dire e del mostrare con verità (esaltando il rischio di un approccio inevitabilmente parziale) contro la pornografia tele-giornalistica imperante e senza chiudersi in una maniera (…) Con la sua ironia elegante, in un’intervista di parecchi anni fa, Resnais attribuiva all’amico e collaboratore Chris Marker il dono dell’ubiquità: opera in posti diversi nello stesso momento ma non lo si incontra quasi mai. Per Segre è un po’ lo stesso: non sappiamo con precisione in cosa sia impegnato e dove ma sappiamo con certezza che lavora e che, presto, ce ne darà conto». (1)
Lo farà ricorrendo all’urgenza, o alla fretta zavattiniana, potremmo aggiungere, e con la lentezza che occorre per contrastare le derive di un cinema povero quanto affannato e la sconfortante semplificazione mediatica dell’oggi.
Come ti è venuta l’idea del film?
Ce l’avevo in mente da molti anni, ma sono sempre stato costretto a rinunciare per mancanza di ascolto da parte dei possibili produttori. Finchè nel 2006, col famoso richiamo del Presidente della Repubblica, ho sentito il bisogno di tornarci sopra. Ho provato a verificare con la Rai, ma non ho avuto nessun riscontro da parte del direttore di Rai3 Paolo Ruffini, così sono partito da solo. Poi, sempre alla Rai, sono tornato con la proposta, ma il servizio pubblico radiotelevisivo ( è ancora un servizio pubblico? ) mi ha opposto indifferenza se non addirittura arroganza. Il sindacato costruzioni CGIL, la Fillea, mi è venuto in aiuto collaborando sul piano organizzativo-logistico; questa collaborazione mi ha permesso di incontrare lavoratori del settore edilizio – avevo deciso di circoscrivere il campo di indagine per tenermi agganciato ad alcune costanti ed evitare le dispersioni – e famigliari. Poi c’è stato anche il sostegno del Piemonte…. La produzione, a ogni modo, è stata interamente sostenuta da “I cammelli”.
Ma l’interesse per l’argomento?
Beh…si può dire sia implicito a tutto il mio lavoro; non mi sono scoperto all’improvviso come il paladino della povera gente. Certo: leggere ogni giorno questo bollettino di guerra, sapere che ogni giorno ci sono quattro morti sul lavoro, toccare con mano l’arroganza di chi dovrebbe dare garanzie e la logica del profitto, assistere allo sfascio di un paese che sarebbe tutto da commissariare: da Trenitalia all’Alitalia…tutto questo, dopo una carriera interamente dedicata all’impegno sociale, ha dato una ulteriore scossa alla mia coscienza civile. E’ stato un altro dei miei viaggi: per fortuna l’ho fatto. Rifiuti e indifferenza invece di abbattermi mi hanno ancor più motivato. La situazione, poi, è davvero drammatica. Qui non si parla di “pensiero debole”, si parla di gente che muore tutti i giorni. Il mio strumento, il cinema, ha solo offerto visibilità a ciò quotidianamente viene negato. Ho solo fatto il mio dovere.
Come hai selezionato storie e personaggi?
Attraverso la Fillea, che ha fatto circolare la notizia nei cantieri, i lavoratori e i famigliari sono stati informati. Chi se l’è sentita di dare un contributo di conoscenza alla questione si è messo in lista e io l’ho incontrato al momento di fare le interviste. Così, dal confronto e dall’ascolto, sono venute fuori le storie da raccontare e i personaggi.
Da che regione hai cominciato?
Ho cominciato dal Lazio, proseguendo poi con la Campania, poi con la Lombardia, e da ultimo, nel novembre 2007 col Piemonte. La lavorazione, le riprese, ecc, sono cominciati dal marzo-aprile del 2007 e sono poi proseguite nel novembre 2008. La tragedia della Tyssen-Krupp mi ha ovviamente spinto ad accellerare i tempi di lavorazione; il film non doveva più essere pronto, come avevo programmato, nella tarda primavera. Ho finito prima, così ho anche avuto l’onore di un’anteprima alla Camera dei deputati il 12 febbraio 2008 e un’altra l’11 marzo al Parlamento europeo di Strasburgo. La realtà, purtroppo, è stata più veloce dei programmi di lavoro e della produzione. Per starle dietro ho aumentato i ritmi miei montando da solo e gestendo in prima persona le inevitabili complicazioni. A ogni stazione del viaggio selezionavo il materiale e lo pre-montavo come se avessi dovuto fare non un film unico ma quattro film regionali. Quando sono arrivato in Piemonte e ho fatto selezioni e pre-montaggio, avevo già messo a punto una struttura quasi definitiva. Questo prima dell’Epifania. Poi ho chiesto un permesso di due settimane alla Scuola Nazionale di Cinema, dove ero impegnato come docente, e sono tornato a Torino per rivedere e dare gli ultimi ritocchi. Tenevo molto a che il film fosse, secondo il mio punto di vista, perfetto. Il film non doveva avere slabbrature, sia riguardo al racconto dell’identità-lavoro, sia per la problematica incidentistica. Mi riferisco all’incidentistica nell’insieme, non solo quella mortale, ma anche quella invalidante, quella che crea contraccolpi pesanti sia sul piano fisico che su quello del degrado mentale, psicologico. E’ stata un’impresa molto impegnativa ma bella; ci ho messo tutta l’esperienza accumulata negli anni sulle problematiche sociali e, alla fine, il film è venuto come volevo: non ideologico, perché i miei film non lo sono mai stati, ma al tempo stesso capace di raccontare la dignità e l’orgoglio del lavoro. Poi, lo dicevo prima, avevo anche intenzione, restituendo la parola a chi se la vede negare da troppi anni, di porre il problema del servizio radiotelevisivo pubblico, ormai ridotto a regime.
Ci sembra che tu abbia usato un “espediente” drammatico nuovo: alcuni personaggi appaiono dapprima come testimoni del lavoro, del mestiere e, ovviamente, del pericolo; poi ci accorgiamo che sono stati vittime di incidenti gravi, invalidanti. E’ un’idea che avevi subito o ti è venuta durante la lavorazione?
La struttura ha preso forma dopo le interviste, che non sono mai preordinate. Valutando la consistenza del materiale a disposizione ho messo a punto una forma di racconto in grado di disorientare uno spettatore già affezionato ai protagonisti per come, sulle prime, gli erano apparsi. Un modo per svelare la forza drammatica della realtà, insomma, evitando una piatta messa in scena della sofferenza. Lo stesso ho cercato di fare col racconto dei morti. Quei tre lavoratori, che di solito non sono neppure chiamati per nome, “parlano” in prima persona, spiegano l’accaduto. Il disorientamento di cui prima dicevo e questa restituzione di voce vogliono dare all’insieme uno specifico equilibrio drammaturgico e uno specifico significato.
Non avevi mai usato la voce di un attore che parla, che racconta su immagini di esterno…
No. Ma stavolta ho sentito il bisogno di ricorrere all’iconografia, cioè di rappresentare dei luoghi… Luoghi esemplari, cartoline: il Golfo di Napoli, il Duomo di Milano, la Mole Antonelliana, l’Altare della Patria a Roma.
L’effetto è molto suggestivo. Hai utilizzato attori professionisti?
Per Brescia mi ha dato la voce una attore che si chiama Luca Gotti, che ha lavorato allo Stabile di Torino ma che per vari motivi famigliari adesso svolge solo un’attività amatoriale. Per Napoli ho utilizzato un sindacalista, Ciro Giustiniani, che mi portava in giro per i cantieri, e che, ho poi saputo, nel tempo libero fa del cabaret. L’ho impegnato per tutta una domenica a studiare; soprattutto a tradurre e adattare in napletano il testo già predisposto. Per la parte del senegalese ha collaborato con me un giovane immigrato che adesso fa il mediatore culturale a Torino ma che a suo tempo ha fatto piccole esperienze teatrali.
Sull’inquadratura dell’Altare della Patria hai messo l’inno di Mameli. Ricorda…..di Lindsay Anderson, un bellissimo documentario sui mercati generali che inizia e finisce con l’inno nazionale inglese. A chi gli chiedeva se cercasse un effetto ironico o sarcastico Anderson rispose di no, lui voleva semplicemente celebrare il lavoro inglese.
Vale anche per me. Facendo ascoltare l’inno io ho voluto settolineare il contributo che i lavoratori in generale, e questi oggi, hanno dato e continuano a dare al progresso e alla crescita del nostro paese. Non a caso l’Altare della Patria è l’immagine di chiusura: loro, questi lavoratori, si sono immolati per il paese, sono caduti ( spesso ignoti, di fatto) come tanti soldati rimasti vittime delle guerre. Avevo usato l’inno nazionale in un altro mio film: Andata e ritorno, nel 1984. Una banda un po’ scalcinata, in un piccolo paese della Calabria, fra il primo e il quattro novembre, celebrava sia la festa dei morti che i caduti della Grande Guerra. Insomma l’inno dovrebbe trasmettere un senso di sacralità.
La parte napoletana sembra la più vivace, anche dal punto di vista narrativo. Forse perché lì hai trovato persone più espressive naturalmente…
Mah…anche gli altri…Certo i partenopei, in generale, sono straordinari…la loro umanità, la loro capacità di esprimersi dà brividi, emozioni, simpatia, tenerezza…I lombardi, invece, sono un po’ più difficili da “aprire”, come i piemontesi, del resto. Sì, certo, i partenopei hanno dato l’ossatura al film. Hanno convenuto subito con me che dovevano parlare la loro lingua, il dialetto. Se avessero parlato in italiano tutto il senso della loro presenza davanti alla mdp sarebbe stato stravolto.
E’ molto toccante anche la parte dei famigliari. E il pudore che hai usato per raccogliere la loro testimonianza.
Credo sia nel mio stile. Nel mio lavoro mi sono sempre addentrato nei drammi. La morte è sempre stata protagonista; le malattie degradanti o terminali, gli incidenti del sabato sera…Credo che la dignità sia un valore assoluto, non negoziabile. E credo anche che da un rapporto con essa dipenda il valore che va oltre il cinema e riguarda il grado di civiltà di un paese. Rispetto e basta. Quindi comprenderete che ogni volta in cui mi sono trovato in situazioni delicate, difficili e complesse – situazioni nelle quali il dolore delle persone ha superato una certa soglia – ho spento la cinepresa e non ho voluto scavare di più per evitare il rischio, facile, di cadere nella morbosità, nella violenza che dissacra l’intimità personale. Insomma c’è un codice etico da rispettare: facendo cinema e oltre.
Un nostro amico psicoanalista, Cesare Secchi, considera il tuo film sull’altzeimer un capolavoro proprio per la leggerezza, il pudore, la delicatezza…E la capacità di far emergere le contraddizioni umane che si esprimono nel malato e in chi lo circonda.
Il mio scopo è sempre trovare uno sguardo leale e obiettivo. Dire le cose come stanno. In Morire di lavoro non ho certo nascosto le responsabilità che, in qualche misura, riguardano anche i lavoratori. I lavoratori le scontano e ne subiscono le conseguenze talvolta per mancanza di cultura…In un certo senso il mio film è “al di sopra delle parti”, cioè riguarda tutti nel momento in cui pone una questione etica davvero generale. Morire di lavoro vuole essere un film per il paese, perché solo attraverso il recupero della dignità umana questo paese “in mora” può recuperare se stesso.
Ci sembra che anche questa volta, ma forse con intensità diversa, la tua esigenza etica trovi un giusto mezzo di stile: Alludiamo all’uso del primo piano frontale, che hai lungamente maturato negli anni. La signora coi capelli grigi, ad esempio, quella che fa cento chilometri ogni giorno per visitare il marito in coma irreversibile…
Agnese Aggio, così si chiama. A un certo punto dice che il coma è peggiore della morte, perché con la morte tu puoi andare davanti a una lapide, guardare una fotografia…Ha ragione, perché da vedova potrebbe trovare una pace che il coma impedisce. Potrebbe elaborare il lutto, trovare un equilibrio…
I piani assumono, ci sembra, un particolare valore iconico, una sacralità, per dirla con Pasolini. Poi impressiona l’intensità costante dell’immagine, il modo con la quale viene distribuita e offerta…
Occorre considerare, riguardo a questo, l’uso che ho fatto del montaggio. La “materia prima”, poetica, me l’ha regalata il destino, nel senso che le persone si sono espresse per quel che erano nel vivo degli incontri. Il montaggio mi ha permesso di mantenere la lucidità, e di evitare facili tranelli. Non a caso ho agito in progressione rifinendo man mano, limando, alla scopo di regolare oltre ai ritmi anche le emozioni. Ciò, senza nulla concedere al “veltronismo”, ci tengo a sottolinearlo.
Riguardo alla sacralità del primo piano frontale essa comincia nel momento in cui vivo fino in fondo la consapevolezza che gli occhi del personaggio si offriranno agli occhi dello spettatore. La consapevolezza oltre che mia sarà poi dello scambio maturo fra personaggio e spettatore e dell’autenticità dell’argomento. Per Morire di lavoro il primo piano mi serviva anzitutto per eliminare i fronzoli, poi ho pensato di alternare i primi piani con “quadri”: gli anziani attorno al tavolo, i giovani sui gradini. Immagini quasi stereotipate: muratori in pausa pranzo, convenzionalmente, poi l’uso di sindacalisti come quinte come nella scena degli infortuni camuffati da malattie con quel ragazzo tatuato. E’ fatto apposta: immagini iconografiche come quelle che si potrebbero usare per una rappresentazione a teatro. L’elemento forte, dentro questa struttura, credo però sia stato la scelta di far parlare i morti. Una scelta di carattere, di stile che dà impronta al racconto. Senza quella avrei fatto solo un documentario. Invece ho fatto l’appello e, all’appello mancavano i morti a cui ho voluto dar voce. Nel coro di questa tragedia contemporanea, allora, ci sono anche quelli che non avevano avuto parola: i morti.
I testi sono sintetici, giusti.
Qui ha giocato l’esperienza. Erano più lunghi, sono stati adattati in dialetto bresciano, in napoletano…è stato inserito il proverbio iniziale del senegalese. I primi piani li ho concepiti usando lampade molto comuni; però ho messo un fondo nero e non ho variato la cromaticità come in altre occasioni. Ho fatto una scelta di lutto: un panno nero come fondale che ha dato uniformità e coerenza fotografica senza penalizzare il valore espressivo dei personaggi. Col fondale nero, la dignità di una situazione di lutto viene ancor più valorizzata. Non hai dispersione cromatica, e così ottieni il massimo di concentrazione; sei sul personaggio, sul volto e basta.
Tornando alla struttura, il film, sul piano narrativo e della gestione dei vari blocchi tematici, appare più elaborato di altri. Tanto che fa pensare a una maggiore complessità anche dal punto di vista produttivo…
E’ stato un esito naturale: intanto io mi sentivo del tutto responsabilizzato in una situazione non facile: ho detto delle barriere, dei rifiuti che mi hanno opposto…L’arroganza della Rai, che avevo scelto come unico interlocutore mi ha offeso anche considerando l’insieme del mio lavoro, l’impegno sociale, e la delicatezza con la quale ho cercato di affrontare argomenti complessi…Poi c’erano le difficoltà produttive, come avete immaginato. In un primo momento non ero sicuro di avere la forza di sopportare tutto l’onere da solo…La mia società, I Cammelli, esiste dal 1981 e me la sono sempre cavata, ma Morire di lavoro mi imponeva un’esposizione particolare: andare in giro per l’Italia, soggiornare…Non sono ricco, lo sapete, ho una famiglia a cui devo provvedere per la mia parte, una società che ha i suoi costi fissi…Però, ripeto, avevo anche la carica particolare che viene dalla consapevolezza di operare “nell’interesse del paese”. Morire di lavoro non è un film come Mitraglia e il Verme o Vecchie…
Certo è una costruzione molto più laboriosa…
Ma che si è definita, come dicevo, naturalmente. Sono partito dagli incidenti, ma poi volevo allargarmi sul lavoro, approfondire il tema. Volevo scoprire, capire come si fa il muratore. Il film si concentra sul lavoro edile, sui cantieri. Ebbene, del mondo delle costruzioni io avevo una conoscenza molto superficiale. Adesso se mi trovo davanti a un ponteggio esercito un’attenzione precisa, ho acquisito una specie di occhio clinico: mi accorgo subito se il pontaggio non è stato costruito a norma, valuto la sicurezza dei lavoratori…Adesso conosco meglio la materia grazie a tutto quel che i lavoratori mi hanno raccontato. Pensate che il montaggio mi ha costretto a sacrifici dolorosi: scegliere una cosa invece di un’altra non meno utile all’economia del discorso.
Al Festival di Torino, quando ancora eri impegnato sulla parte piemontese, in conferenza stampa hai fatto l’ipotesi di una versione a capitoli regionali…
Sì, ma più che altro tenere in mente il lavoro fatto in una regione mi è servito per mettere a punto, progressivamente, il quadro nazionale. Sapevo sempre, durante la lavorazione, fino a che punto ero arrivato e a quale grado di profondità. Insomma il film è venuto fuori gradualmente e gradualmente ha assunto spessore: come se, man mano che procedevo, si perfezionasse dando evidenza a quel che s’era ordinato, appuntato nella mia testa. Poi, con la tragedia della Tyssen, ho accellerato i tempi e mi sono sottoposto a un tour de force “di fabbrica”: turni e straordinari.
E’ un film polifonico. Più polifonico di altri, anche se si avverte sempre la tua soggettività…
E’ vero. Tanto che posso dire di aver immaginato i personaggi come i personaggi di un coro in un melodramma, in un’opera tragica. Ne ho parlato anche coi miei più stratti collaboratori: un coro, una tragedia contemporanea. Quanto alla soggettività, credo di aver messo nel lavoro una tensione, e una rabbia anche, che all’inizio, quando portavo in giro il film, faceva velo a quella che credo sia la verità di fondo: io sono uno dei personaggi che non compaiono, sono un’appendice, sono uno di loro.
Ma, nel tuo lavoro, quanto conta la preparazione (la razionalità) e quanto l’intuizione.
La razionalità è fondamentale; è un supporto strategico sia per definire un disegno produttivo che per la creazione. Il tutto però è regolato da un istinto attraverso il quale la scelta si impone. In apparenza molti miei film nascono dalla casualità: lo stimolo arriva dalla Tv, da una notizia letta su un giornale, da un appello del Presidente della Repubblica… anche il rapporto con i personaggi e con gli attori si definisce partendo dall’intuizione; Vecchie è nato in una sera in trattoria e il mese dopo era pronto. Non so spiegare…Mitraglia e il Verme si deve all’osservazione di un particolare a casa di uno dei protagonisti, Stefano Corsi…dopo mezz’ora avevo già in testa il titolo del film…E’ un fenomeno psicologico attraverso il quale le cose vengono fuori in una forma quasi compiuta. Ma con l’immediatezza c’è anche la fiducia di chi lavora con me o da me si lascia interrogare. Non tradisco. Per esempio, tornando a Morire di lavoro: quell’uomo di Napoli che ha perso un braccio nell’ingranaggio, per venti minuti, quando abbiamo cominciato a girare , era bloccato. Non so bene come sono riuscito a sciogliere la sua tensione ma poi è successo. Io ho insistito – sapevo che l’infortunio lo aveva portato sull’orlo della depressione – e l’ho fatto cercando di essere gentile e rasserenante ma, al tempo stesso, di attribuire alla sua testimonianza tutta la necessità che aveva. Di farglielo sentire. Così ha capito che doveva rivisitare il suo dramma con coraggio: E’ difficilissimo farlo, soprattutto davanti alla macchina da presa. Devi superare un dolore sapendo che altri se ne accorgeranno, e devi aver chiaro che questo è un atto di elevata responsabilità.
1)Tullio Masoni e Paolo Vecchi, Un cinema con, un cinema per, un cinema contro. L’attitudine maieutica di Daniele Segre, in, Angela Gregorini, a cura di, Un’amorosa visione. Il cinema della realtà fatto da ragazze e ragazzi, Il lavoro editoriale, 2008, pag. 70.