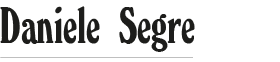Alberto Barbera / A qualcuno piace d’Essai
Difficile non rimanere sedotti dall’ultimo lavoro di Daniele Segre. anche se non si è facili agli entusiasmi e tentati dalle iperboli. Ho detto lavoro non per una pur comprensibile reticenza a usare la parola film a proposito di un prodotto che. tecnicamente è piuttosto un video (di fatto, si tratta di un BVU colore della durata di 60 minuti e 35 secondi).
E neppure, perchè Daniele Segre avrebbe in animo di farne una trascrizione su pellicola e, data la qualità dell’immagine, a cose fatte potrebbe sfuggire ai più l’originaria matrice elettronica. Il fatto è che questa disponibilità a passare senza traumi da un supporto all’altro (in singolare sintonia. questa volta, con il “contenuto” del lavoro che parla di transessuali e, dunque, di esseri che passano da un sesso all’altro, anche se non sempre senza traumi), é uno degli elementi caratteristici del cinema di Segre. Daniele mi sembra anzi uno dei primi registi della nuova generazione di filmaker per i quali l’integrazione di filmico ed elettronico non è una prospettiva con cui dover fare i conti, ma un dato di partenza, un fatto acquisito: non un destino ineluttabile di corruzione dell’aureo mezzo espressivo, ma una mera questione tecnica di supporti differenti ma assimilabili sul piano del linguaggio.
Ho parlato anche di seduzione. In primo luogo. l’argomento attiene alla forma stessa del lavoro del regista. C’è un metodo Segre, evidente sin dai primi lavori ma affinato nel corso del tempo e delle numerose produzioni successive. Detto in breve, consiste anch’esso in un paesaggio continuo e quasi impercettibile di campo: dal documentario alla fiction, e viceversa. Assunti non già come momenti successivi per quanto interagenti, ma precisamente come istanze discorsive simultanee, scivolamenti progressivi da un piano all’altro all’interno della medesima sequenza. della medesima inquadratura. Si tratta insomma per Segre di complicare in continuazione l’evidenza del documento con lo spessore della rappresentazione, senza peraltro mai sovrapporre artificialmente la messa in scena alla “naturalità” del reale. Indagini d’ambiente, di costume, di casi umani, di condizioni materiali, i film di Segre più riusciti sono anche viaggi all’interno di un immaginario particolare, avventure della psiche e dell’emozione individuale, proprio perché capaci di operare dall’interno secondo una logica di rispetto dei fatti e dei personaggi, con una scrittura razionale che lascia parlare le cose, cioè le immagini. Per questo, il cinema di Segre non è mai cinema “di commento”, moralistico o sociologico. Per questo, dà i suoi risultati migliori quando il metodo è applicato senza scarti, senza la presunzione di voler sovrapporre allo “splendore” del vero la grana grossa di una storia poco lavorata, come è capitato al sincero ma deludente “Testadura”.
Di questo metodo, “Vite di ballatoio” (presentato in anteprima nazionale alla conferenza stampa del 2° Festival Cinema Giovani di Torino) è l’esito più maturo e più convincente. Perché formalmente più controllato, grazie anche al contributo di una fotografia poco “televisiva” e molto curata (a firma pseudonimi di Bruno Adamo) e all’eccellente montaggio del più sensibile tra i montatori del nostro cinema (Roberto Perpignani). E, soprattutto, perché più felice nella delicata scelta delle soluzioni espressive, mai banali ma neppure contaminate dal rischio incombente del “pittoresco” e del “morboso”. Segre ci dà un ritratto lucido e intenso di un gruppo di travestiti e transessuali immigrati, sradicati dal loro ambiente d’origine, costretti alla prostituzione, protesi alla ricerca di un’identità “impossibile” e di una felicità contingente, costretti a fare i conti con la “normalità” di un’esistenza anomala. Il suo sguardo e freddo e analitico, senza essere cinico o indifferente, anatomizza una situazione, evidenzia la fattualità di un ambiente mettendone in luce i tessuti connettivi, le fibre emotive. le tenioni “fisiche”. Racconta frammenti di storie, ricostruisce brani di vissuto, assembla elementi di una rappresentazione, avendo semplicemente l’aria di spiare l’estraneità di un “fenomeno” poco conosciuto, di sorprendere l’evidenza di una cronaca della marginalità più radicale.
In ciò aiutato dalle “naturali” (ma non per questo meno sorprendenti) doti di autorappresentazione dei travestiti. Il risultato è un eccellente esempio di cinema della realtà che non può lasciare indifferenti e di cui si ricorderanno a lungo alcune sequenze esemplari: il travestito che, prima dei titoli di testa, canta “tu si ‘na malafemmena” e, più avanti, recita un brano da Filumena Marturano; il rito quotidiano dei trucco; la discussione sui soldi tra “moglie” e marito (a letto di fronte alla tv), la trepidazione del travestito che s’informa sull’operazione (“dicono che poi si gode”). E, soprattutto, la livida sequenza conclusiva che svela le reali ambizioni del film e survolta l’inquietudine trattenuta dello spettatore. Mentre Mina, il transessuale, mima in play-back la canzona di Farida e Renato Zero, “Mister uomo”, un travestito si denuda al centro della scena, i segni della femminilità confusi e sovrapposti a quelli della indelebile mascolinità. E rimane li, immobile, schiaffeggiato dalla luce di un proiettore: cortocircuito tragico-grottesco di una condizione ai confini dell’umanità.