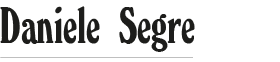Beatrice Manetti / La Repubblica Firenze
Metafisica e cronaca nera. A pensarli insieme vengono in mente gli asparagi e l'immortalità dell'anima di Achille Campanile. Ma a farli incontrare, con evidente giovamento reciproco, ci è riuscito Ross McElwee in The six o'clock news, uno dei documentari più avvincenti, per quanto appesantito da qualche inutile lungaggine, presentati in concorso nella quarta giornata del Festival dei Popoli. Da anni McElwee gira documentari che lui stesso insiste a definire autobiografici.
Si tratta in realtà, e fortunatamente, di un autobiografismo che guarda molto oltre la circonferenza dell'ombelico dell'autore. E anche se in questo caso lo spunto è offerto da una contingenza familiare -la nascita del primo figlio, che costringe il regista a passare più tempo a casa e inevitabilmente a cibarsi di tv – da un caso personalissimo e per niente sorprendente di videodipendenza l'orizzonte si allarga ben presto su altre curiosità.
è il notiziario delle sei, col suo convulso repertorio di catastrofi naturali e tragedie premeditate, ad innescare la prima domanda: che fine fanno le persone e i luoghi saliti per un attimo alla ribalta delle cronache tv, quando le telecamere li lasciano? La risposta, come accade spesso nella buona letteratura americana, è ancora una volta «on the road». Ma lungo il suo viaggio, tra un pomeriggio passato con le vittime di un tornado e la festa di compleanno di un operaio salvadoregno miracolosamente sopravvissuto al crollo di un garage durante un terremoto, altre questioni incombono. Dove è il confine tra casualità e fatalità nel tiro di dadi che devasta una casa e risparmia quella accanto? E cosa significa che una notizia è vera, quando i canali televisivi americani straripano di ricostruzioni in studio di fatti di cronaca «realmente» accaduti? Sono le due ossessioni che implicitamente attraversano e scandiscono il viaggio di McElwee alla ricerca di ciò che sta «dopo la notizia»: quella tipicamente americana per l 'ordine e il controllo del mondo, che neanche Dio sembra più avere, e quella del regista per l'ambiguità sostanziale della propria opera, fedele a una realtà che non è mai una sola, ma che nasce e si manifesta da subito in versioni multiple. Il tutto senza sentenziosità né pedanteria, lasciando emergere la riflessione direttamente dalle storie dei suoi interlocutori, e intrecciando con sorprendente equilibrio reportage di cronaca, minimalismo narrativo, massimi sistemi e lievissima ironia.
Se McElwee ci fa viaggiare per due ore, e senza noia, sulla sua macchina di «easy rider» con la filosofia sul portapacchi, Daniele Segre condensa cinquant'anni di storia italiana nella platea del cinema Novecento di Cavriago, Emilia Romagna. In posa contro i fondali iperrealisti del suo Pareven furmighi, un gruppo di anziani del paese racconta lo sforzo collettivo per costruire la sala negli anni dell'immediato dopoguerra. Fatica di mani, i mattoni comprati uno alla volta con i risparmi della settimana, le gite in bicicletta per prendere la ghiaia, i ricordi delle prime proiezioni. «Tutti parteciparono – racconta un vecchio comunista – anche i democristiani e i cattolici. Per noi fu il segno della riconciliazione». La guerra di liberazione e il Gassman di Riso amaro, la tolleranza reciproca nei conflitti politici e i primi passi di boogie. Come in un Nuovo cinema paradiso che diffida di stucchevolezze nostalgiche, Daniele Segre racconta – sono parole sue – «la parte migliore dell'Italia, quella capace di assumersi delle responsabilità». Anche la responsabilità di regalarsi un sogno, mattone su mattone.