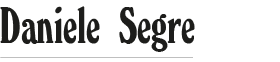Maria COLETTI. in a cura di Lino Miccichè “Schermi opachi. Il cinema italiano degli anni ‘80”
Circa dieci anni fa, in una sua riflessione sul panorama cinematografico italiano degli anni Ottanta, Mario Sesti lamentava la sistematica mancanza di “una funzionale e motivata metodologia di documentazione; che è un modo per nominare quel1`opacità di sguardo sull’esistente, quella mancanza di penetrazione e capacità di conoscenza e rappresentazione delle cose che ha caratterizzato larghissima parte non solo dello standard industriale cinematografico, ma anche le sue opposizioni indipendenti, libere e giovani” . Considerando retrospettivamente l’esperienza dei giovani indipendenti, appare chiaro come la promettente stagione cinematografica sviluppatasi intorno ai poli di Milano e Torino e consolidatasi negli incontri di Film-maker e di Bellaria si sia in realtà esaurita nel giro di pochi anni. Anche i1 tentativo di dare vita, attraverso la cooperativa Indigena , a una piattaforma, a una rete produttiva che unisse, sul modello della tedesca Filmverlag der Autoren, le forze dei giovani film-maker è fallito. Anziché una scuola, una tendenza, un nuovo modo di pensare, di fare e di produrre cinema, si sono distinte e affermate solo isolate personalità. Il rischio -che si è puntualmente verificato – era quello di cadere e di rimanere intrappolati in uno dei due estremi: il circuito autoghettizzante dei film-maker o dei video-maker indipendenti, esteticamente autonomo ma condannato il più delle volte a un’eterna amatorialità; oppure la prospettiva assistenziale dell’articolo 28 e il compromesso con i gusti del pubblico o,peggio, con i dettami del cinema commerciale.
In questo contesto, l’esperienza ventennale di Segre appare in tutta la sua particolarità e importanza, proprio nella continuità della sua opera e nella coerenza dimostrata nel perseguire e nell’affermare un suo metodo. Una continuità e una coerenza difese a denti stretti, grazie anche alla consapevolezza che la libertà non può mai prescindere dalla professionalità. “Il cinema indipendente deve dare un’immagine di sé più perfetta del cinema ufficiale. È ora di finirla con i balbettamenti, con il sonoro incomprensibile” , aveva dichiarato lo stesso Segre nell’anno in cui si affermò ad Anteprima per il Cinema Indipendente Italiano di Bellaria con Ritratto di un piccolo spacciatore (1982), presentato fuori concorso, e con Vite di Ballatoio (1984), vincitore del Gabbiano d’Oro. E ancora, qualche anno più tardi: “Io faccio il regista, ma sono anche un imprenditore; in quanto tale devo saper fare i conti se voglio continuare a fare il mio mestiere. Altrimenti, del film che voglio fare, probabilmente rimarrebbe integro soltanto il titolo; tutto i1 resto sarebbe stravolto da esigenze occasionali del mercato” .
Ed è proprio grazie a questa consapevolezza che Segre è riuscito, nel corso degli anni, non solo a uscire dal ghetto e a conquistarsi un pubblico (alternando e realizzando parallelamente film in pellicola, in video, documentari e programmi televisivi ) ma anche a realizzare una propria casa di produzione, I Cammelli, e a portare avanti il progetto Cammelli Factory, che comprende la produzione di altri lavori di documentazione sul territorio e la Scuola Video di Documentazione Sociale. Due momenti, questi, centrali nell’ottica del suo lavoro, sempre attento, da un lato, all’osservazione delle realtà con cui entra in contatto e, dall’altro, all’eredità del suo metodo, alla formazione di una nuova generazione di registi che sappiano guardare e documentare la realtà con occhi liberi da ogni pregiudizio etico ed estetico . Una formazione che però è sempre vissuta da Segre anche nell’ottica dell’auto-apprendimento, di uno scambio e uno stimolo reciproci tra maestro e allievi. Una formazione alla documentazione sociale che non sia semplicemente tecnologica, ma soprattutto umanistica, perché non basta essere padroni del linguaggio cinematografico e, magari, saper fare bene la pubblicità, se non si è in grado di capire la funzione pubblica del mestiere di regista, il ruolo sociale del cinema. Quello che preme a Segre è “la riattivazione di sensibilità o la destrutturazione di alcuni vincoli “ideologici”, culturali, che a volte impediscono ai ragazzi di avere semplicemente il coraggio di uscire nella realtà, di conoscerla. Perché “realtà” come parola riempie la bocca, ma nei fatti fa paura” .
Del resto questa sensibilità, questa capacità di cogliere i1 reale nelle sue sfumature e nella sua essenzialità al contempo, fa parte del bagaglio professionale di Segre che, prima ancora di essere documentarista e regista, nasce come fotografo. Il suo primo, decisivo contatto col cinema lo ha, infatti, facendo il fotografo di scena per Nessuno o tutti/Matti da slegare (1975) di Agosti, Bellocchio, Petraglia e Rulli e poi per La macchina cinema (1978) degli stessi autori. Ed è nel segno di questa significativa esperienza che Segre comincia a realizzare documentari, inchieste e servizi giornalistici, occupandosi per lo più di fenomeni di devianza e marginalità sociale. Molte di queste prime opere nascono proprio come esperienza sul campo, come lavori fotografici prima che come inchiesta (Ragazzi di stadio, 1979) o docu-fiction (Vite di ballatoio).
La formazione variegata e “contaminata” di Segre non può che dare vita a opere altrettanto contaminate, a un metodo il cui tratto dominante è proprio la compresenza di realtà e finzione, documentazione e rappresentazione. Un metodo contenuto in nuce nel già citato Ritratto di un piccolo spacciatore: la videocamera si posa apparentemente fredda e distaccata sulle pareti, sugli oggetti, sul corpo del suo personaggio-attore (di cui non inquadra mai il volto), ma non rimane indifferente. Si instaura un rapporto partecipe tra regista e attore, al di là della formula dell’intervista che rimanda allo stile tradizionale dell’inchiesta, un rapporto in cui l’attore si conquista il suo spazio, il proprio diritto alla parola, ad autorappresentarsi. Dal rispetto reciproco nasce allora, nello spazio claustrofobico di un appartamento qualunque, un canto liberatorio che restituisce identità e volto a un’umanità negata, rimossa, dimenticata, come la realtà spiacevole e perturbante che rappresenta, e a nome di cui parla.
Questi continui slittamenti, sconfinamenti tra realtà, finzione e autorappresentazione divengono ancora più evidenti nei due film successivi: Testadura (1983), in cui il regista mette a nudo la propria storia e quella dei propri amici, le inquietudini e le utopie di una generazione, con uno stile impietosamente sincero, lontano dalla moda giovanilistica o dal pigro “guardarsi l’ombelico” di tanti giovani autori; e, più ancora, Vite di ballatoio. Questo video, montato da Roberto Perpignani, segna in qualche modo un punto di non ritorno per Segre, la messa a punto definitiva dello stile che ha mantenuto fino a oggi, approfondendolo e perfezionandolo. Le storie di alcuni transessuali meridionali ripresi nei momenti quotidiani della loro esistenza, nelle cosiddette “case a ballatoio” della Torino operaia del primo Novecento, vengono “raccontate” in prima persona dagli stessi protagonisti. Nessuna intervista, né tantomeno una voce fuori campo a commentare cioò che si può solo guardare con occhio partecipe, come la telecamera di Segre, presenza invisibile e discreta, che riesce a entrare in intimità con i protagonisti, a essere quasi uno di loro. Qui la duplicità del reale e la duplicità dei personaggi, che sono al contempo se stessi e attori, va oltre la compresenza di realtà e finzione dei primi lavorii di Segre, al punto che diventa quasi impossibile distinguerle. I transessuali sono persone riprese mentre vivono la loro vita, zavattinianamente “pedinate”, e nello stesso tempo attori che mettono in scena situazioni che però rimandano alla propria esperienza: in qualche modo sono dei meta-personaggi, che vivono e si guardano/si mostrano vivere, in quanto il cine-occhio di Segre funziona come strumento ottico ma anche come specchio. Non è un caso che il video si apra e si chiuda con due canzoni (la famosa Malafemmena e Mister uomo di Renato Zero e Farida) che, cantate e recitate durante uno spettacolo da alcuni protagonisti, stanno a sottolineare proprio l’elemento fittizio.
Anche l’uso del sonoro rispecchia questa ambiguità linguistica, questa contaminazione che riguarda forma e contenuto dei film di Segre. Al piano della documentazione corrisponde naturalmente l’uso del suono in presa diretta, il far parlare le persone riprese ognuna con la propria voce e il proprio accento. Ma nel tessuto narrativo sono disseminati momenti in cui l’autorappresentazione dei personaggi e l’intervento interpretativo del regista esplodono e si disvelano in tutta la loro forza: può essere l’effetto straniante di una musica usata come colonna sonora o dei rumori di fondo, una canzone cantata dai personaggi oppure, soprattutto in alcuni lavori degli anni Novanta, una vera e propria performance teatrale delle persone-attori, inserita nel film come una pausa di riflessione.
Ciò che sta alla base di tutto il cinema di Segre è dunque proprio la sua volontà di porsi allo stesso tempo come testimonianza e stilizzazione del reale: ricerca delle radici individuali e collettive e insieme riduzione della realtà e dei personaggi alla loro comune essenza, alla loro umanità. Una “riduzione del reale” che finisce per essere anche stilistica, nella progressiva tendenza di Segre a denudare i meccanismi della finzione e a far prevalere su tutto il personaggio: tendenza sempre più evidente nei lavori successivi, anche in quelli che sembrano tornare a una formula più semplicemente documentaria. Ad esempio in Andata e ritorno (1984), in cui Segre si confronta con l’amara realtà dell’emigrazione e della disoccupazione nel Mezzogiorno attraverso i paesaggi e gli abitanti di Pazzano, un piccolo paese della Calabria. Nel ritrarre i personaggi e le storie, tutte diverse e tutte uguali, perché segnate allo stesso modo dalla fatica, dal lavoro e da una dignitosa rassegnazione, il regista torna alla formula dell’intervista, ma in modo mediato: è un giovane compaesano emigrato a Torino che, in visita al suo paese natio, pone interrogativi, si interroga e si confronta con quelli che sono rimasti.
Anche in Occhi che videro (1989), ideato e sceneggiato insieme a Davide Ferrario, torna l’uso dell’intervista. Ma il film, dedicato al Museo del Cinema di Torino e alla sua fondatrice, Maria Adriana Prolo, pur nascendo come documentario su un pezzo di storia del cinema italiano, si trasforma in una specie di incarnazione della memoria stessa del cinema, con i primi piani intensi della Prolo (indimenticabili i suoi occhi vivi e sognanti da eterna bambina), l’atmosfera rarefatta e di sogno creata dai lenti e avvolgenti movimenti di macchina e il pulviscolo argenteo che circonda le attrezzature e da cui sembrano materializzarsi i brani di repertorio inseriti nel film. Ma questa capacità di Segre di dare a fatti e personaggi “storici” una dimensione magica e fuori dal tempo può anche mutate di segno e tramutarsi nel suo contrario: come in Non c’era una volta (1989), in cui il regista restituisce visibilità e concretezza a un’umanità un tempo negata e rinchiusa nella realtà “altra” dei manicomi.
La coesistenza di documento e finzione, cui si è prima accennato, questi continui rimandi interni ed esterni dalla vita al cinema e dal cinema alla vita, sono dunque presenti in tutti i film di Segre, fino a toccare, forse, il punto più alto con la perfetta circolarità dell’ultimo lavoro del regista, Pareven furmighi (1997), in cui la costruzione di una sala cinematografica diventa memoria storica e cinematografica, individuale e collettiva. Ma è a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta che questa stilizzazione, questa accentuazione dell’aspetto metalinguistico prende il sopravvento, a partire da alcune “opere-cerniera”. Già in Partitura per volti e voci – Viaggio tra i delegati CGIL (1991), realizzato, sulla base di un’idea nata nel 1988, durante i corsi di formazione per delegati di base, Segre concentra tutta la sua attenzione sui volti e sulle voci dei circa 67 delegati “intervistati”. Gli sfondi neutri, artificiali, la distanza fissa dalla telecamera, l’esplicita situazione da inchiesta (che ricorda il Pasolini di Comizi d’amore), tutto richiama e sottolinea l’artificiosità dell’operazione; eppure, anzi forse proprio per questo, la verità umana e politica di queste persone esplode e si fa strada sullo schermo, raccontando sull’Italia di quegli anni più di quanto riescano a fare l’informazione televisiva abituale o i documentari di partito.
Volti e voci, dicevamo. E in effetti é come se, grazie a questa formula, che si ripeterà con variazioni in tutti i film successivi, Segre riesca a dare visibilità al pensiero, a tradurre la parola in immagine, in un modo che non può non ricordare l’insegnamento e l’esperienza del Rossellini (soprattutto) televisivo. Come rosselliniane sono anche la sua formazione “integrale”, la ricerca di una padronanza assoluta del mezzo (dalla sceneggiatura alla regia, dalla produzione al montaggio) e l’importanza data alla didattica e alla formazione permanente. Un paragone tanto più valido se riferito all’atteggiamento morale — anche se mai moralistico — che Segre ha nei confronti delle persone—attori che ha di fronte. Il suo cinema non cade mai nella trappola dell’ideologia, nel pericolo di guardare e interpretare la “realta in modo preconcetto, per trovare solo ciò che si vuole trovare e vedere solo ciò che si vuole vedere; al contrario, restituisce integrità alle realtà e alle persone che riprende, restituisce loro la propria identità e le proprie radici. C’e sempre un rapporto diretto, umano, dialettico tra Segre e i suoi personaggi, un rapporto basato sul rispetto e sull’influenza reciproca, un lavoro sul campo che richiede tempo, pazienza, fiducia.
Un mettersi in gioco costante esemplificato egregiamente dall’esperienza umana e artistica maturata in seguito all’incontro con Carlo Colnaghi, con cui Segre realizza il video Tempo di riposo (1991) e il film Manila Paloma Blanca (1992), girato in 35 mm e sceneggiato insieme a Davide Ferrario. Il video nasce come sinopia, come lavoro preparatorio al film, come percorso che permetta a Colnaghi, ex attore che ha “staccato la spina dalla realtà” ed è stato ricoverato in ospedali psichiatrici, di recuperare le proprie capacità attoriali e insieme il rapporto con la realtà e con se stesso. Ma oltre a tutto ciò Tempo di riposo è anche un’opera autonoma, in sé conclusa. Colnaghi, che è anche co-autore del soggetto del film, padroneggia magistralmente i vari piani espressivi, passando con forza e naturalezza dalla confessione/intervista all’autorappresentazione, alla recitazione vera e propria (nella sceneggiatura sono inseriti brani da Shakespeare, Büchner, Pinter). Un’ambiguità linguistica ed espressiva che ritornerà anche nel lungometraggio: messi a confronto con il colore dell’azione vera e propria, gli inserti video in bianco e nero, sgranati, sembrano davvero l’inconscio, il rimosso, gli incubi, ma anche la realtà più profonda e più vera del protagonista che esplodono con violenza sullo schermo. E sono anche l’inconscio del cinema, e quindi anche dello stesso Segre, che si mette sempre più sullo stesso piano dei suoi personaggi.
Accanto al processo di stilizzazione prima accennato, sono riconoscibili dunque come elementi chiave del cinema di Segre una sorta di cortocircuito linguistico, per cui i1 testo del film diventa lo stesso personaggio, e un meccanismo di riconoscimento e di rispecchiamento reciproci tra regista e attore. Quello di Segre può essere letto come un atteggiamento e demiurgico e maieutico al contempo: da un lato esprime se stesso e la propria autorialità, ma anche le proprie inquietudini, “modellando” la realtà umana del suo interlocutore; dall’altro aiuta i1 personaggio-attore a trovare e a esprimere la propria verità. Un meccanismo di rispecchiamento che mette in discussione il concetto stesso di rappresentazione e che coinvolge anche lo spettatore nella necessità di questo mettersi in gioco: si crea un circuito comunicativo triangolate tra regista, attore e spettatore che non può attivarsi se non attraverso un processo di autoanalisi. In questo scavo in profondità di tutto ciò che è abitualmente rimosso, nel sociale e nel privato, si verifica un triplice disvelamento: del regista, nel suo documentate e insieme interpretare una realtà; del personaggio, che “recita” e si rappresenta al contempo; dello spettatore, che è chiamato a sua volta a mettersi in discussione, a riflettere sul proprio modo di vedete, di vivete e di interpretare la realtà. Nei film di Segre i1 ruolo dello spettatore non è mai passivo, non si ferma alla semplice risposta emotiva, frenata del resto dall’evidenza dei meccanismi stessi della rappresentazione, ma implica sempre una distanza, un immedesimarsi e poi staaniarsi (come i1 metodo attoriale dello stesso Colnaghi) che permette la riflessione.
Ecco che allora il cinema di Segre ci appare tanto più vicino alla realtà quanto più sembra allontanarsene nei modi della rappresentazione, quanto più il suo linguaggio appare contaminato e stilizzato. Viceversa, anche nei lavori più apertamente realistici e di denuncia sociale, sono sempre rintracciabili momenti autoriflessivi, come accade ad esempio in Crotone, Italia (1993) e Dinamite (Nuraxi Figus, Italia, 1994) che possono essere considerati due “instant-video” rispettivamente sulla rivolta degli operai Enichem di Crotone e sull’occupazione dei minatoti sardi della Sulcis contro la chiusura delle miniere di carbone. Qui Segre rispolvera in un certo senso il linguaggio dell’inchiesta, cercando di fare informazione nel modo più corretto possibile, di dare corpo e voce a realtaa sociali troppo spesso dimenticate, di delineare le responsabilità morali e politiche di un governo latitante. E riesce molto bene in tutto questo. Ma i momenti forti dei due film sono, in fondo, proprio i primi piani dei protagonisti, i racconti delle loro storie e delle loto idee e speranze. Come dimenticare il volto segnato e teso del minatore pronto a far esplodere la dinamite, i suoi occhi spalancati, disperati e insieme pieni di dignità, nel dire: “Non siamo terroristi, difendiamo solo i1 posto di lavoro”? Così la discesa della videocamera nelle viscere della miniera diventa anche una discesa negli inferi, una discesa nel sé e nel cuore della realtà e nello stesso tempo un simbolo del modo di fare cinema di Segre, della sua capacità di guardare in faccia la realtà, anche nel suo “orrore”, di scoprire il vero volto delle cose e delle persone.
Esemplare, in questo senso, ci appare il lavoro fatto da Segre per Come prima, più di prima, t’amerò (1995), un video sui malati di AIDS che inaugura una serie di lavori coprodotti da RAI 3 su temi quali l’immigrazione, le “stragi del sabato sera”, il lavoro, la terza età . Con questo video Segre porta ulteriormente avanti i1 discorso sulla stilizzazione, arrivando all’astrazione: la luce è crepuscolare, gli sfondi sono anonimi, i vestiti dei protagonisti semplici e comuni, privati di ogni traccia del loro passato. I personaggi, seduti da soli o in gruppo, sono inquadrati in primo piano o a figura intera mentre parlano tra loro, col regista o a se stessi. Qui diventa ancora più palese l’identità di forma e contenuto, poichè all’astrazione formale corrisponde l’universalità dei temi affrontati dal video. Anche se si tratta di malati di AIDS, infatti, Segre riesce a vedere e a farci vedere il volto dietro la loro maschera: non una “categoria a rischio”, ma donne e uomini più o meno giovani costretti a confrontarsi prima degli altri con la morte e che, forse proprio per questo, riflettono più attentamente sul senso della vita, sull’amore, sul sesso, sui rapporti interpersonali. Ma questi sono temi universali, con i quali ciascuno si confronta: lo spettatore pensa di
scoprire, di trovarsi di fronte l’Altro, e invece trova se stesso. Come in uno specchio. E proprio la scoperta dell’identità nell’apparente diversità ci preserva dalla demonizzazione, dall’esorcizzazione di ciò che viene temuto come “orrore” e che invece è una parte di noi stessi, della nostra vita. Come uno dei protagonisti non attori ha molto lucidamente scritto a proposito del film: “La sieropositività si scopre allo specchio per quello che essa è: una maschera tragica dell’attuale condizione umana. Mai come in questo tempo, di guerre dimenticate e di facili egoismi, l’uomo ha paura, forse, di guardarsi allo specchio, temendo di scoprirvi il volto terrificante di Medusa» .
E proprio la figura di Perseo mi sembra quella più adatta per cogliere e per riassumere il senso, il cuore del cinema di Segre, di questa lunga catena di volti che si inchiodano nella nostra memoria di spettatori. Secondo la mitologia, Perseo (raffigurato con sandali alati e con l’elmo di Ades che rende invisibili, non può anche essere considerato come la prefigurazione dell’utopia della leggerezza, della mobilità e dell’ubiquità della macchina da presa, inseguita dai kinoki di Vertov come dai cinegiornali liberi di Zavattini?) riuscì a sconfiggere la Medusa usando lo scudo come uno specchio per evitare il suo sguardo pietrificante. Allo stesso modo Segre ci difende dall’orrore pietrificante della realtà, ci permette di sostenere il suo sguardo e di non restarne impietriti, proprio perché i suoi film diventano anche il nostro specchio, ci permettono di (ri)trovare una parte di noi stessi. E l’orrore si trasforma magicamente in splendore, come dalla testa mozzata di Medusa si narra che Perseo abbia tratto un mostro ma anche il cavallo alato Pegaso. Guardare in volto la realtà, calarsi corpo e anima nelle sue mille verità e viverla fino in fondo può significare anche perdersi, come confessa Colnaghi in uno dei suoi monologhi:
Voi lo sapete bene dove finisce i1 palcoscenico… Io non lo so… Credete che basti una ribalta per fare un palcoscenico… Fate ridere. Io sono stato per le strade, sono stato anche in America, ho visto cose che voi leggete solo nei libri. Ho visto la povera gente recitare una parte senza sapere chi l’aveva scritta per loro. Miserabili, gente in catene, fame. L’ho visto e questo mi ha fatto scappare. Mai più una cosa del genere.
Il cinema è allora davvero quello strumento magico che, come lo scudo di Perseo, permette a Segre (e anche a noi, come uomini e come spettatori) di non scappare, di non pietrificarsi, di non chiudere gli occhi davanti alla miseria e allo splendore del vero.
———————————————-
M. Sesti, Le storie: come non si scrivono (più), in Cineforum, a.27, n.1-2 (261), gennaio-febbraio 1987, p.18.
Sorta nel 1985, Indigena ha prodotto, tra le altre cose, il film collettivo Provvisorio quasi amore (1988), cui Segre ha partecipato con l’episodio Sarabanda e finale. Gli altri episodi del film sono: Sirena di Francesca Marciano, Antonio e Cleo di Silvio Soldini, Imperfetto orario di Kiko Stella, Occasioni di shopping di Bruno Bigoni, Gelosi e tranquilli di Enrico Ghezzi, Blue Valentine di Roberta Mazzoni.
P. Vecchi, Un cammello con la macchina da presa: conversazione can Daniele Segre, in
“Cineforum”, a. 24, n. 9 (237), settembre 1984, p. 42.
E. Martini, Intervista a Daniele Segre, in “Cineforum”, a. 27, n. 5 (264), maggio 1987,
p. 47.
Mi è sembrato opportuno, in questa sede, limitarmi ad analizzare la produzione più strettamente “autoriale” di Segre, a cavallo tra documentario e finzione. Per una filmografia più completa e riferimenti precisi ai servizi e ai programmi televisivi si rimanda a A. Maraldi (a cura di), Il cinema di Daniele Segre, Cesena, Centro Cinema Città di Cesena, 1993.
Un buon esempio è senz`altro il video Real Falchera (1991) di Giacomo Ferrante, Renato Ricatto e Enrico Verra, un prodotto della Cammelli Factory e della Scuola Video di Documentazione Sociale, che ha ottenuto il Premio Filmaker di Milano e il Gabbiano d’Oro ad Anteprima per il Cinema Indipendente Italiano di Bellaria.
D. Segre, Perché siete venuti qui? Riflessioni .sull’insegnamento della videodocumentazione sociale, in S. Lischi, P. Piazza (a cura di), A occhio nudo. La Scuola Video di Documentazione Sociale I Cammelli, Torino, Lindau, 1997, p. 107.
Si tratta di Diritto di cittadinanza, Sei minuti all’alba, Un solo grido, lavoro e Quella certa età, tutti realizzati nel 1996.
Esse, Sieropositività: realtà o maschera? La nostra maschera.., in “Traparentesi”, supplemento al trimestrale dell’Associazione A77, a. 3, n. 2-3, settembre 1995, p. 10.