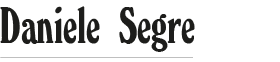Maria Nadotti / Traparentesi
Come rispondere con il cinema alla strategia culturale che il sazio e stordito nord del mondo ha intessuto attorno al copione della sieropositività e dell’Aids? Finora, soprattutto da Stati Uniti, Francia e Inghilterra ci erano arrivati preziosi documentari prodotti da piccole e avvertite comunità locali. Materiali girati a caldo, per dare voce e visibilità a gruppi ed esperienze di margine, per lo più rimosse, irrapresentabili se non da chi ne era protagonista, poco appetibili sul piano del consumo di massa. Testi pensati per far riflettere, affermare, controinformare soprattutto i diretti interessati, sieropositivi, persone con l’Aids, operatori e attivisti.
A fianco di questa produzione ormai sterminata e che pure – non solo per una resistenza del mercato ad assorbirla e farla circolare – è rimasta limitata ad un circuito militante in grado di farne buon uso, si è assistito ad un proliferare di piccole e grandi fiction. In un primo tempo film narrativi rigorosamente indipendenti, spesso scritti, diretti e prodotti da chi il virus Hiv se Io era ritrovato nella vita di tutti i giorni, la propria e quella del proprio ambiente.
Ne è prova New York che, a partire dai primi anni ottanta, si trasforma in una necropoli incapace di rappresentarsi al di fuori di una dolente presa d’atto dei nuovi scenari disegnati dalla malattia e dal lutto. In una sorta di sforzo collettivo che va al di là di una logica della solidarietà i suoi migliori artisti e intellettuali si mobilitano per raccontare e interpretare quella che ben presto si qualifica come la nuova frontiera della convivenza civile contemporanea. Arrivano poi – ma è storia recente e ancora tutta da valutare per moventi ed effetti – i primi prodotti commerciali a tema, i film di cassetta a grosso budget e cast miliardario, come Philadelphia, destinati a glamourizzare il virus di fine millennio e a farne l’oggetto ideale di un melodramma consolatorio e in fondo inoffensivo. Sottratto ad ogni riconoscibilità sociale e ad un vero impatto politico, il copione dell’Aids si stempera in un sentimentalismo generico e buono per tutti gli usi. I protagonisti della tragedia si trasformano in santini senza diventare personaggi, negandosi e negandoci la complessa ambiguità propria di una vicenda collettiva che ha saputo, invece, rimettere in discussione i termini di ogni relazione pubblica e privata, la nostra idea di chi siamo e di chi siano gli altri e riattivare sentimenti a lungo taciuti o repressi, paura, rifiuto, viltà e vergogna.
L’Italia cinematografica è nel frattempo, rimasta a guardare. Occupati, i nostri autori, almeno i migliori, in opere di grande impegno civile, eppure incapaci di misurarsi, o forse semplicemente di sentire come cosa loro, l’urgenza e I’ineludibilità dei problemi sollevati dall’Aids.
Che oggi sulla scena italiana compaia un’opera come quella di Daniele Segre è dunque una specie di piccolo miracolo e un segno da raccogliere con estrema attenzione.
“Come prima, più di prima, t’amerò”, sessanta minuti di parlato a più voci, nasce per desiderio di un’associazione milanese, A77, che da anni si occupa di disagio, sieropositività e Aids.
L’urgenza che spinge i suoi fondatori a rivolgersi a uno dei filmmaker italiani più attenti ai conflitti che attraversano la società è semplice: raccontare con la propria voce invece di nascondersi nel silenzio, nel vittimismo, nella recriminazione; parlare, invece di lasciarsi parlare; assumersi la responsabilità di dire di sé uscendo da un sistema di delega e di dipendenza. Ma anche fare il punto su anni di duro e appassionato lavoro collettivo che hanno prodotto saperi e sensibilità nuovi e la capacità di sovvertire ogni paternalistica logica assistenziale.
Senza negare e negarsi la fatica e la complessità di un processo che si regge sulla costante volontà di ripensare, disfare, tentare altre strade. Con attenzione e delicatezza. Con enorme rispetto per la dignità umana. Senza regole prestabilite e senza retorica. Con quella spregiudicatezza che può nascere solo da una vera passione per gli altri, chiunque essi siano e qualunque sia la storia che li ha portati ad essere ciò che sono. Sulla scena di “Come prima, più di prima, t’amerò” compaiono, non a caso, solo persone, una ventina circa, che hanno deciso di non fare mistero della propria sieropositività e però anche, di non farne una professione, una identità. “lo non voglio essere prima di tutto il volto di un virus”, afferma in una delle testimonianze iniziali un giovane uomo che ha scelto di presentarsi con il volto coperto da una maschera, non per mantenere l’anonimato, ma “perché la gente non vuole vederci, vedermi per quello che sono, vedere il mio cuore e dunque si merita la maschera.”
Già, perché nelle belle pagine filmiche di Segre il rapporto voce narrante – spettatore è fin dalla prima sequenza, ribaltato. Davanti a noi sfilano tante persone qualunque, programmaticamente omologate da un abbigliamento non connotato – giacca e cravatta per gli uomini, abiti neutri per le donne – che non rimanda ad alcuna “storia precedente”, ad alcuna sedicente “categoria a rischio” e rende impossibile capire chi abbiamo di fronte a prescindere da ciò che scelgono di dirci di sé.
E quel che ci viene raccontato è il loro presente di uomini e donne giovani che hanno in comune la sieropositività e un’acuta capacità di pensarsi, di pensare il tempo, la malattia, la probabilità di una morte precoce, ma anche la relazione con gli altri, una strenua e mai rabbiosa volontà di vivere fino in fondo la propria umanità, la tenerezza del desiderio amoroso, la paura di essere respinti, esclusi, abbandonati, l’angoscia della solitudine, la ricerca di senso, lo smarrimento e l’allegria di fronte alla promessa di un affetto che non cancelli il corpo e non lo riduca ai suoi sintomi, la voglia e il terrore di fare un figlio, di essere madri e padri non solo a se stessi. Temi familiari a tutti noi, in fondo brutalmente banali, eppure affrontati qui con un di più di consapevolezza, con la dolcissima e dolente lucidità che è di chi non può e non vuole permettersi facili rimozioni e comode amnesie.
Di chi non può dimenticarsi di essere mortale. Nell’ora del film, interrotti qua e là da fugaci e intensi brani di vera liturgia teatrale (a monte vi sono i laboratori di attività corporea organizzati da A77), i protagonisti – soli, a coppie, in piccoli gruppi – raccontano e analizzano, si interrogano e ci interrogano, spalancano voragini di inquietudine e trovano risposte che spesso i cosiddetti sani non arrivano neanche a cercare. “Il tempo”, dice una donna, “va usato perché non sappiamo quanto ne abbiamo. La gente non si rende conto della reale concretezza del tempo, se ne accorge solo quando è passato. Magari a sessant’anni, quando si ritrova a chiedersi che cosa ha fatto della propria vita. Ma è tardi”. Un film freddo e rovente, questo “Come prima, più di prima, t’amerò”, rarefatto e densissimo insieme, pudicamente spudorato, mai sentimentale.
Un tentativo riuscito di strappare il copione dell’Aids alle metafore prodotte dal pregiudizio e dalla paura della nostra, contraddittoria umanità.