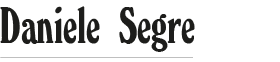Tullio Masoni, Paolo Vecchi
Dal libro “Daniele Segre – Il cinema con la realtà” a cura di Antioco Floris – Cuec Editrice
Andrej Tarkovskij ha descritto il rapporto fra cinema e realtà con parole felicemente suggestive: «Il cinema — affermava in un’intervista — è il simbolo della realtà». Il prodigio più grande della “settima arte” consisterebbe dunque nel suo farsi specchio e simbolo insieme, nell’innescare un corto circuito dove la verosimiglianza trasfigura nel fantastico e il fantastico torna alla verosimiglianza con la velocità del lampo. Attraverso il filtro tarkovskijano potremmo leggere gli esiti più recenti della ricerca di Daniele Segre, non per inventarci paragoni stravaganti, ma per verificare come il rapporto cinema-realtà teorizzato dal maestro russo sia applicabile a esperienze diverse e fra loro lontane.
Nell’ultimo periodo, il regista torinese ha messo a punto una scrittura vieppiù consapevole, ha cioè accentuato l’azzardo di una proiezione fantastica sul reale — anche quando sono di scena la cronaca o l’esercizio dal vero e dal vivo — che in modo latente informava alcuni dei primi lavori. L’esempio più calzante per spiegare tale consapevolezza ci viene proprio da Paréven furmìghi (1997), il video “ad alta definizione” (non nel senso della tecnologia ma dell’accuratezza) che Segre ha realizzato a Cavriago, un comune della provincia di Reggio Emilia dove la nuova multisala “Novecento” è sorta sulle fondamenta di un cinema-teatro costruito da un folto gruppo di volontari nei primi anni Cinquanta. La cooperativa fondata in quella occasione si chiamava “Coop. Casa del Popolo”, ed è la stessa che, assieme al comune, gestisce la struttura odierna. L’autore chiama in causa i vecchi cooperatori con l’idea di indagare su un fatto eccezionale — come si potrebbe chiamare diversamente la costruzione di un cinema-teatro in un periodo di povertà profonda e diffusa? — e compie un prezioso esercizio di scavo, mobilitando, oltre agli inconsueti protagonisti, gli allievi della propria scuola. Ne risulta innanzitutto una costruzione metaforica bivalente. Da un lato, questo sforzo collettivo rimanda ad una vocazione solidaristica (quella catena umana dall’Enza a Cavriago), parte integrante del sangue e della cultura di una terra che, come ricorda qualcuno, è cresciuta nel socialismo e nell’antifascismo.’ Dall’altro, ripropone le modalità della “macchina cinema”, nell’accezione wagneriana di Gesamtkunstwerk, opera d’arte totale delle cosiddette pratiche basse, ma soprattutto come lavoro collettivo, architettura alla cui realizzazione è fondamentale il contributo anche dell’ultimo figurante — se vogliamo rimanere alla metafora, del più umile portatore di mattoni. In questo senso, appare evidente il suo legame con Non ti scordar di me (1994) e, seppure in maniera più sfumata, con Occhi che videro (1989), riflessioni sul cinema da parte di un regista il cui atteggiamento con eufemismo molto blando si potrebbe definire anti-cinefilo. Il film sul museo caparbiamente voluto a Torino da Maria Adriana Prolo sembra di primo acchito un corpo estraneo nella produzione di Segre, soprattutto quella ad esso coeva: per l’atmosfera magica, sospesa, irreale; per il tema, la rappresentazione della finzione, anzi, dell’amore per gli strumenti che la producono. Eppure, il filo conduttore c’è: la ricerca della verità profonda, nell’equilibrio tra rispetto e coinvolgimento verso la realtà che scaturisce dalle cose, dalle persone. Qui un solo personaggio occupa la scena, l’amorosa e ferrea conservatrice, borgesiano demiurgo tra mondo reale ed emisfero separato delle ombre, ma quella che lei ci racconta è una storia concreta, di soldi, mura, difficoltà e passione. Il video sui generici di Cinecittà partecipa viceversa di quella dimensione corale (una “partitura per volti e voci”, appunto) che caratterizza l’ultima produzione del regista. In questa galleria di personaggi che, conquistando la gloria del primo piano dopo una vita spesa da comprimari, possono finalmente esibire appieno carica di simpatia e carature professionali, si sottolinea ovviamente l’orgoglio di chi ha contribuito, in un ruolo oscuro ma fondamentale, agli splendori della “Hollywood sul Tevere” («Bisogna dare film di movimento, e il movimento è dato dalle masse», afferma un personaggio; «La regina delle battaglie è la fanteria», proclama un altro prima di fare l’appello). Ma, anche se nessuno è riuscito a tirar fuori dallo zaino quel bastone da maresciallo che, secondo Napoleone, ciascuno si portava appresso, se le loro storie personali parlano di fame e sopraffazioni (e Segre, con megafono e berretto d’ordinanza, sembra mettersi in discussione come ennesimo perpetuatore di un rapporto autoritario), il inondo della celluloide conserva intatto il proprio nitore mitico, non fosse altro che per la sua capacità di registrazione sub specie aeternitatis (“il cinema si fa per lasciare un’impronta”). Aver recitato a fianco di John Wayne e Orson Welles attribuisce comunque quarti di nobiltà, magari solo perché consente il privilegio di un dismagamento aneddotico (Alan Ladd che era piccolo e “mbriaco come na cucuzza”). E, forse involontariamente, di quest’aura rimane traccia nell’incedere dei generici che, con meno nonchalance ma con la stessa solennità dei borghesi bunueliani, attraversano le vestigia di una Cinecittà ancora memore dei fasti di un tempo.’ L’incipit di Paréven furmìghi ruota addirittura attorno al corpo filmico di Riso amaro, praticamente coetaneo della sala cinematografica la cui costruzione il video celebra. Tuttavia, neppure un fotogramma del capolavoro di Peppe De Santis viene utilizzato. Se ne possono ascoltare frammenti di dialogo mentre la camera, con un lento carrello laterale, trascorre dai volti degli antichi cooperanti a quello dei ventenni di oggi, a testimoniare la continuità di una serie di valori (l’impegno politico e sociale, ma anche l’attaccamento alla terra) di una regione più volte citata nell’epica perorazione finale sulla salma della sventurata Silvana Mangano. Anche la sua “trama”, come si diceva una volta, è raccontata in maniera grintosa ed esilarante da una delle “attrici”, che, dopo essersi spesa in un’analisi sanguigna e tutt’altro che banale del neorealismo, ricollega immediatamente quei tempi alla propria esperienza personale di soubrette improvvisata, a sedici anni, in un’imbarazzante parte di prostituta nella rivista allestita da un gruppo di dilettanti, racconto concluso dalla deliziosa esibizione canora sulle note di Je suis seul ce soir. Il cinema, insomma, prosciugato di un fin troppo facile alone di separatezza, entra in gioco come elemento — importante e fascinoso, certo, ma uno fra i tanti — nella definizione di identità.
Avviato come lavoro sul campo e inchiesta, Paréven furmìghi si offre man mano in una luce sorprendente e rivela uno scambio fra reale e fantastico del tutto nuovo. La realtà, sembra dirci, si può affrontare solo mettendo in gioco il soggetto-autore in forme tormentate oltre che inedite. è un gioco rischioso ma necessario, nel quale le parti devono restare ben visibili: non più l’equivoco, pur generoso, dell’aderenza all’oggettività, della replica fedele o dell’abbandono all’ “autonomia” delle cose, ma l’autodenuncia dell’autore che elegge se stesso a filtro, che si dichiara interprete restando perennemente in bilico fra “debolezza” — cioè disponibilità — e forzatura della responsabilità individuale. La responsabilità di chi, ammettendo un ruolo decisivo nel lavoro, ma parziale verso l’oggetto, cerca poi di andare fino in fondo e di esporsi.
In altri momenti Segre ha fatto rientrare l’intreccio fra debolezza e responsabilità in una rivitalizzata idea di decadentismo: «Per me è naturale — sottolineava in un’intervista — nel senso che da quando ho iniziato ad esprimermi, prima come fotografo, poi come regista, ho sempre sentito l’esigenza di esprimere la mia diversità e la mia unicità sul piano del linguaggio, e di avere questo rapporto di immedesimazione con i miei problemi e quelli degli altri, in una sintesi che possa generare un coinvolgimento comunicativo. Ed essere decadente credo costituisca la mia linfa vitale». Paréven furmìghi spinge il sentimento e la concreta posizione dell’autore fino a segnalare l’esterno” come virtù creativa e la debolezza del singolo di fronte alla complessità come irrinunciabile occasione; Segre incontra i protagonisti dell’impresa leggendaria, li fa rivivere e partecipa della loro memoria ma, nel medesimo tempo, cerca il distacco utile, cioè taglia, regola, pulisce, monta e organizza. In altre parole, fa di tutto per sfuggire alle insidie del naturalismo della cronaca, alle lusinghe del colore locale e alla trappola dei sentimenti populisti, per restituirci il vero dei personaggi (tali diventano, sottoponendosi alla sua regia, i testimoni) in un vitale senso di precarietà. Le vecchie foto dell’impresa compiuta dalla “Coop. Casa del Popolo” ricordano magari certe incisioni di Tono Zancanaro, ma il colore scenico, la piccola mitologia evocata e la franchezza dell’esposizione ad una fiction tutta visibile, assaporabile come tale e “moderna”, inducono a rimanere nell’oggi. Certo c’è il passato, e c’è la nostalgia che al passato si accompagna, ma ciò nonostante il film si mantiene a mezz’aria fra la storia depositata —oggettiva — e l’occhio esterno dell’autore. Il gioco di Segre riesce perciò in una singolare ambizione di “durata”, ossia scommette sulla compre-senza di temporalità diverse per strappare la memoria dal museo e restituirla alla vita. Così il sogno rievocato da facce e voci vere, da personalità di anziani consapevoli di avere una storia ben degna da raccontare, si nobilita al presente attraverso la finezza dello stile, prende corpo nella faticosa ricostruzione idiomatica che i personaggi accettano di praticare — in ciò “forzati” dal regista — contro la tradizione del galateo-telecamera.
Paréven furmìghi , infine, è un film a mezz’aria non solo per la durata che tiene in equilibrio temporalità diverse, ma anche letteralmente, cioè per la sua inusitata leggerezza. Quella che rievoca leggera non sarebbe, ma Segre sa farcela percepire come storia di passaggio, vicenda precaria di persone autenticamente vive. Una storia di desideri nati dalla realtà ma sospinti oltre: desideri collettivi e di ciascuno; desideri anche nostri, di spettatori, che come i personaggi ci specchiamo nello schermo illuminato con felicità e coscienza di inganno.
Ad esiti così maturi Segre è arrivato dopo un lungo percorso, fatto di tentativi molteplici ma, bisogna riconoscerlo, di poche incertezze.
O, almeno, di incertezze così scoperte da meritare, quasi subito, la dignità dello stile.
Il momento di svolta, dopo il quale il cammino del regista ha proceduto con crescente chiarezza di scopi, può essere individuato in Partitura per volti e voci, un lavoro “commissionato” dall’Ufficio nazionale di formazione della Cgil nel 1991. Per molti versi, l’impresa ricorda i progetti di ricerca teorizzati — o meglio immaginati con geniale confusione — da Cesare Zavattini, che, come in altra occasione ci è capitato di sottolineare, potrebbe essere considerato come il profeta del mezzo leggero e del giornalismo visivo fondato sull’inventiva di massa. ‘ Partitura per volti e voci non ha niente da spartire con la “maniera” televisiva egemone (e neanche con le poche eccezioni della RAI monopolistica); sembra, al contrario, suggerire una tensione di verità di cui abbiamo perso memoria. Vale in proposito una bella frase di Godard: «Oggi si sanno forse costruire sequenze perfette, ma non si sa pensare. Pensare il nuovo, riflettere sopra e sotto la comunicazione». Ciò premesso, le differenze che Partitura per volti e voci segna da Zavattini e dalle forme di realismo consacrate dal cinema italiano del dopoguerra sono sensibili. Intanto per il ruolo dell’ideologia, che in Segre è forte quanto “sospesa”, come abbiamo già visto, cioè riverberata nelle scelte operative e nello stile ma riassunta in un atteggiamento morale sciolto; poi, per la sorte, diremmo quasi l’invenzione del “personaggio” e per il rapporto con lo spettatore. «La scelta stilistica diventa anche una scelta politica — ha dichiarato il regista alla presentazione del video — Loro (i delegati intervistati, ndr.) sono stati molto al gioco e alla fine, nelle cose che dicono, ho ritrovato molto di me stesso. Anche se sembra un film oggettivo, Partitura dice moltissimo di me come persona. Ho colto in loro le cose che mi appartengono e le ho fatte mie. Soprattutto la voglia di cambiare, di lottare. Io ci credo». Come sembra evidente, Segre non teme gli anacronismi e ama mettersi individualmente in gioco. La moralità della sua opera trae origine da questa franchezza e, lo anticipavamo, dal rischio costante di una caduta libera che può mettere in discussione sia la bontà dei rapporti con gli interlocutori che l’efficacia mediatica (cioè la funzione di propaganda) del programma comunicativo.
Quanto alla sorte del “personaggio”, il discorso diventa più difficile. Se, a proposito dell’ideologia, abbiamo osservato che Segre non si preoccupa di nasconderla nel tòpos drammaturgico o addirittura nel bozzetto, come facevano tanti autori realisti o neorealisti, ma preferisce dichiararla piegandola al primato della morale sulla politica, per il personaggio e la mediazione che incarna entra in gioco un diverso rapporto fra schermo e spettatore. Vorremmo dire che l’esperienza di visione introdotta da un film come Partitura per volti e voci agisce poco nelle convenzioni del senso comune e invece stimola un approccio singolo, se non addirittura solitario. Nello spazio fra lo spettatore e lo schermo —uno spazio che si allunga impregnandosi di approcci “personali” —emerge allora una nuova opportunità per il testo, per la parola: il testo si raccoglie nel personaggio contribuendo a caricare di senso l’inquadratura, vive e “si mostra” in una sintesi più severa. Le convenzioni drammaturgiche alle quali ogni ambizione realista ha finito per sottoporsi lasciano così il posto a un confronto serrato con la verosimiglianza, e dunque a una reinvenzione — anche letteraria — nella quale la reciprocità tra il film e chi lo guarda (per altri versi tra filmico e profilmico) è sempre più necessaria.
Quanto detto vale per Partitura per volti e voci, dove la trama “segreta” delle alternanze, delle minime variazioni di piano e delle voci, agisce sotto una superficie ruvida ma preziosissima; e vale ancor più per Tempo di riposo, dove l’attore si dichiara esplicitamente, rendendo assai stretto lo scambio fra testo scritto — poi recitato — e testo che si reinventa in divenire: «Tempo di riposo — ci diceva Segre — è stata una nuova stazione importante rispetto al mio modo di lavorare, ragionare e interpretare la realtà, in questo caso portando l’esasperazione del linguaggio a livelli ancora più alti rispetto a Vite di ballatoio, per fare un esempio. Qui c’è stata una ulteriore contaminazione fra la finzione e la realtà. In questo caso disponevo di uno strumento — un attore — che mi permetteva anche più possibilità di giocare in questo terreno strano, ambiguo, in cui ritrovo sempre meglio la mia identità come regista».
Siamo dunque, per restare al confronto con i realismi, al “personaggio” che non si traveste con l’anonimato (la “gente qualsiasi” dell’esperienza neorealista) e nemmeno si esercita in una pura occasione istrionica; siamo al personaggio che fa testo grazie a un mezzo particolarmente spietato, che propone un testo, che non trasmette un “carattere” ma piuttosto un’esperienza attiva sullo spettatore.
Così come non ha paura dell’anacronismo dei temi — quello operaio, ad esempio, così ignorato se non addirittura irriso dagli anni Ottanta in poi —, Segre si compiace di dare al proprio lavoro di cineasta e di insegnante una sigla desueta: documentazione sociale. A ben vedere, il concetto non era estraneo neppure al lavoro degli esordi —pensiamo a quell’esperimento schematico ma illuminante che è stato Testadura (1983), avvio di un viaggio nella città, Torino, che si sarebbe compiuto in Manila Palma Bianca (1992), ed esposizione di un bisogno, la parola, che avrebbe investito la sensibilità di un’intera generazione in crisi — ma con gli anni ha assunto spessore di “avanguardia”. Partendo da una marginalità di ambienti nella quale ha saputo cogliere molti significati della vita contemporanea, il regista ha unito la ricerca linguistica a quella concreta di ruolo sociale: «Credo di sapere chi sono — ci diceva — e, più o meno, quello che voglio. Certi contatti mi hanno angosciato generando degli incubi relativi a quello che sono io, a quello che voglio essere e, essendo il cinema — o comunque questa forma che ho scelto per comunicare — un lavoro collettivo, alla necessità di stabilire delle alleanze. Negli anni passati (Segre fa riferimento agli anni Ottanta, ndr) c’è stata con molta serietà la voglia di creare queste alleanze, che purtroppo hanno generato il nulla: grandi velleità, tempo perso. Tempo di riposo in fondo mi ha aiutato a recuperare la serenità perduta, a rimettere a fuoco in uno scenario devastato i bisogni che mi appartengono». Abbandonate certe alleanze, Segre ha insomma coltivato quelle proprie al suo particolare “decadentismo”; altre alleanze in un mondo altro, dove può riprendere significato la finalità di una democrazia davvero adulta: «Mi piace molto il termine radici. — rispondeva a una nostra domanda — lo sono sempre alla ricerca di questo elemento; l’altro termine che mi è molto congeniale è identità. Radici e identità sono elementi totalmente mancanti in questa nostra fase storica. Stiamo andando verso una situazione di fascismo diffuso ed è fondamentale recuperare determinati valori per rispondere democraticamente a queste insulse provocazioni. Partitura è l’espressione più alta dell’identità culturale, delle radici storiche di un movimento che comunque ha permesso all’Italia di restare democratica. Io ci credo, altrimenti non esisterei, non continuerei una battaglia quotidiana per mandare avanti la mia esistenza». 9
Può sorprendere l’accostamento del soggetto operaio a quelli che, da luoghi sociali molteplici, formano la sensibilità “decadente” del nostro regista? In un primo momento sì, ma poi, a pensarci meglio, ci si accorge di un’alleanza — ancora fenomenico-poetica — tutt’altro che improbabile. Segre agisce su questa materia, lo abbiamo già sottolineato, attraverso un costante affinamento di forma e di stile. Giunge così a un’immagine “non solo cinematografica e non solo televisiva”, a una sintesi che offre opportunità visive inedite — cioè di utile e autoriale trasfigurazione — al contatto con la realtà. Perciò il lavoro collettivo riprende quota, organizzare una scuola ha senso, come cresce di importanza l’apporto dei collaboratori: «La scelta espressiva così rigorosa del primo piano — Segre in questa dichiarazione faceva riferimento a Partitura per volti e voci — necessitava di un partner creativo all’altezza. Ho pensato che Paolo Ferrari potesse darmi quello di cui avevo bisogno». E in verità Ferrari assurge al titolo di autore a sua volta, in Partitura come in altri lavori (si veda, in particolare, Sei minuti all’alba, 1996, in cui la sgradevole artificiosità delle luci avvolge i personaggi in un’atmosfera da discoteca ma anche da horror cronenberghiano, incartando il loro vuoto interiore con i colori sinistri dello sradicamento, della perdita di identità, della morte), dimostrando come, da una scuola professionalmente qualificata ma forse troppo subalterna agli standard del superspettacolo come quella di Vittorio Storaro, si possa variare, innovare poeticamente e cercare una verifica. Detto in altri termini, l’acrilico calore delle immagini create da Ferrari per film come Partitura rende giustizia a uomini e donne, tirando fuori chiari e scuri inconsueti, tonalità “pubblicitarie” che nel nuovo contesto si negano come tali e abbattono le vecchie convenzioni del film militante. «Siamo agli antipodi dell’iconografia tradizionale, — diceva il regista — l’iconografia banale e stupida, seguendo la quale molti autori militanti hanno lavorato non per il sindacato, ma contro il sindacato». ”
Si parlava prima di Zavattini. Un’altra teorizzazione del Grande Luzzarese che potrebbe attagliarsi a certo Segre è quello di cinema della fretta, termine usato a proposito del progetto utopico dei “Cinegiornali liberi”. Il regista, come sappiamo, ha di solito una sua tecnica di approccio che prevede un percorso di documentazione che può essere piuttosto lungo, per capire ambiente, situazione e personaggi. Vediamo un esempio significativo, nel racconto dello stesso regista. «Vite di ballatoio conclude un lavoro di ricerca durato due anni e mezzo. La chiamo ricerca perché l’ho sviluppata gradualmente, con una tecnica simile a quella di Ragazzi di stadio, per il tipo di “lavoro sul campo”, nel senso che l’ambiente è molto difficile e anche pericoloso, non tanto per i personaggi in sé, quanto per l’umanità che grava intorno ad essi. Ho prima dovuto farmi accettare dai protagonisti. C’era una rosa di persone che mi interessavano, che poi piano piano sono diventate sette o otto, anche perché avevo bisogno di personaggi, altrimenti, onestamente, il mio cinema non esisterebbe. è stato un lavoro graduale… Da parte mia c’era anche la volontà di dimostrare una certa coerenza di scelta, e non mistificazione di rapporti, e uso strumentale che si poteva avere nei loro confronti, come “oggetti interessanti”, sempre per mass-media ma in modo sempre uguale, di stigmatizzazione, di aumento di pregiudizio da parte dei “normali”. Il mio obiettivo, però, era un altro, e dovevo dimostrarglielo e diventare loro amico, stabilire un rapporto. Ci siamo arrivati con calma, senza fretta, e forse è derivata da qui la forza del film, perché c’era la coscienza da parte di tutti quanti che si raccontava una storia in cui ognuno era protagonista, e non c’era nessun padrone. Io pdi ero il regista che cercava di coordinarli e di guidarli in modo che non perdessero l’occasione che capitava loro, perché sarebbe stato terribile perderla, non si poteva sbagliare». Questo metodo, sociologico e psicologico insieme, che ha qualche punto di contatto con le teorizzazioni dello Studio Béla Balàzs e trova riscontro nei migliori risultati del cinema ungherese di docu-fiction (da Istvàn Darday fino al grande Béla Tarr), Segre lo utilizza, con variazioni legate alle peculiarità del momento, nelle sue opere più “pensate”, con una struttura compositiva robusta e complessa. Talora, tuttavia, il suo istinto “militante” (più di rado la commissione) lo porta a precipitarsi sulle situazioni nel loro divenire. E sono straordinari, in questi casi, la sua capacità di cogliere immediatamente il nucleo dei fenomeni, il fiuto nell’individuare i personaggi, l’abilità a legare le loro storie. è il caso, ad esempio, di Crotone, Italia (1993) e, sia pure in misura minore, Alla ricerca del centro (1994) e Dinamite (1994). Il film in cui questa attitudine si rivela, esprimendosi probabilmente al livello estremo, è Ritratto di un piccolo spacciatore (1982). In uno spoglio interno di periferia, la telecamera registra le esibizioni del protagonista, un trafficante di “roba”, sempre ripreso dal collo in giù, che, con una torrenzialità dovuta solo in parte ai cocktail di eroina e cocaina, recita da attore consumato con il corpo e le braccia, perfino, si direbbe, con la sigaretta accesa, risponde al telefono, riceve ospiti-clienti, improvvisa musica e parole di una canzone su droga ed esistenza, accumula con caotica lucidità aforismi di filosofia spicciola, esibendo una personalità forte e canagliesca, non dissimile da quella del junkie dello straordinario mediometraggio di Martin Scorsese American Boy (1978), che peraltro Segre dice di non conoscere. Cinque ore di girato per 38 minuti di video, frutto di un evento imprevisto, e della duttilità di Segre nel prenderlo al balzo. «è la storia di un incontro casuale, in un bar, di notte, a Torino, l’incontro di due persone, uno che va a cercare un pacchetto di sigarette e uno che invece sta spacciando eroina. Modalità dell’incontro sono stati proprio il caso e la simpatia reciproca su un gioco di parole e niente di più. Conscio lui di quello che io penso degli spacciatori, quindi un rapporto leale, corretto, nel rispetto da parte mia nel mantenere l’anonimato di questo personaggio, pur non rispettando io il ruolo che in quel momento rappresentava. Sono entrato in casa sua e abbiamo iniziato a girare, ma niente era preventivato, io non sapevo neanche come era fatta casa sua, non sapevo niente… Lui era veramente un attore in quel momento, e io lo dovevo condurre sulla strada che stavamo inventando di volta in volta. Però non si trattava solo di un discorso di autorappresentazione, che avevo portato avanti fino a quel momento con altri miei lavori precedenti, ma piuttosto di interpretazione… Uso ancora l’intervista perché l’ho ritenuta necessaria, come ausilio conoscitivo di un personaggio per il quale c’era in me l’esigenza di capire delle cose, anche rispetto al tipo di funzione che doveva avere poi il filmato, a livello di informazione e comunicazione. E c’è stato quasi un accordo tacito fra me e lui, ci siamo rispettati, definendoci e dandoci i ruoli. Io ero il regista, e lui mi chiamava “regista”, cioè quella persona che lui aveva incontrato per caso al bar e con la quale a lui interessava avere un rapporto… Io ero affascinato per il fatto che scoprivo con lui una dinamica narrativa che non dico non mi appartenesse, ma che, forse, per mancanza di coraggio, avevo diluito nel tempo, nel corso dei miei lavori. Ci stavo forse arrivando, ma con i piedi di piombo. Lui mi ha imposto uno scarto. A quel punto bisognava solo accettare o non accettare, cioè seguire la sua storia o imporre il mio potere. Chiaramente, ho preferito seguire lui». ” Per entrambe le situazioni, diciamo così, narrative, quella derivante da un robusto lavoro preparatorio e quella più affidata all’intuizione, abbiamo lasciato largo spazio alle dichiarazioni di Segre non solo perché esemplificano in maniera lucida un metodo, un calarsi naturale e discreto (in alcuni momenti di Vite di ballatoio addirittura non si percepisce la mdp). Colpisce soprattutto il rispetto per le persone che diventano soggetti narrativi, un rapporto non autoritario, non violento, che si instaura tra la camera e il campo di ripresa. Lasciando ovviamente da parte gli orrori della “televisione del dolore”, siamo agli antipodi delle pur interessantissime ricerche di Silvano Agosti, che trovano il loro acme in D’amore si vive (1984), dove il regista coinvolge — certo con volontà provocatoria — i personaggi intervistati (il bambino, la prostituta, il transessuale, la figlia del prete) e lo spettatore in un vero e proprio brainstorming in cui ciascuno, a seconda di sensibilità e predisposizione, è costretto a partecipare con le viscere, a mettersi (troppo) pesantemente in discussione. Certo, Segre
entra dentro ben più di quanto non faccia, ad esempio, il Silvio Soldini di Voci celate (1985), davvero esemplare per nitore e discrezione del tutto in linea con lo “stile” del regista milanese. Coi suoi personaggi, a volte, fa anche baruffa, ma sempre nell’ambito dello stimolo, di una dialettica necessaria per far funzionare la macchina, avendo infine la meglio persino sui caratteri più decisi, come la ottantottenne di Quella certa età (1996) che conclude dicendo al regista: «Lei è simpatico. Non lo è stato quel giorno là, ma oggi lo è», e afferma convinta che il “giochetto” comincia anche a piacerle. Il rispetto è un’altra faccia del rigore e della moralità che informano anche le sue scelte sul piano mediatico e linguistico, dell’equilibrio nel dosare ambiguità e provocazione, partecipazione e distanza (si veda, ancora una volta, il caso limite di Ritratto di Un piccolo spacciatore).
L’austerità” del cinema di Segre non si traduce però, come si potrebbe paventare, in preclusione del divertimento. Forse, anzi, una parte consistente della sua opera si può leggere in chiave di commedia. A cominciare, ovviamente, dal più volte citato Vite di ballatoio. Come già abbiamo anticipato, il film entra nelle case del centro di Torino che ospitano i transessuali, prevalentemente pugliesi. Usando come cornice due canzoni che s’intitolano, in maniera significativa, Malafemmena e Mister Uomo, la prima cantata dalla calda voce di contralto di un travestito, la seconda da Farida e Renato Zero e mimata durante uno spettacolo di cabaret che si conclude con uno spogliarello, ci mostra le apprensioni, i timori, le gioie, il lavoro, il banale quotidiano di questa frangia di umanità. I fili di ogni singola esistenza vanno a comporre un tessuto narrativo che ci introduce senza disagio anche nelle situazioni più lontane e diverse. Ma la regìa, pur perseguendo un suo rigoroso progetto complessivo, non rinuncia a valorizzare il talento, in qualche caso davvero istrionico, dei singoli, lasciando spazio all’improvvisazione, come nella strepitosa sequenza del colloquio sul letto tra un travestito ancora “uomo”, che, pieno di tentazioni ma anche di indecisioni (“Ma poi, si gode?”), chiede a un “operato” notizie sulla sua nuova condizione, fisica e psicologica; oppure, si concede significative intrusioni comiche, come la cena davanti al televisore della coppia omosessuale, che riproduce, caricaturandola, una “normalità” piccoloborghese. Tornando alla produzione più recente, ci pare indubbio che di questa dimensione partecipino anche Non ti scordar di me, Quella certa età e Paréven furmíghi, visti a torto da qualcuno come una serie di epitaffi alla Spoon River. Nel film sui generici di Cinecittà, ad esempio, è certo palpabile un senso di malinconia e rimpianto, ma l’insieme ci sembra lontano da tonalità funebri, prevalendo la carica di vitalità e simpatia dei singoli rispetto alle considerazioni, peraltro d’obbligo, sulla fine dei tempi eroici, di Cinecittà e per ciascuno. Questa tendenza è ancor più tangibile negli altri due titoli. Quella certa età, oltre a ribadire un atteggiamento in qualche modo “solare” (ogni età ha la sua bellezza, le sue soddisfazioni, i suoi piaceri, la passione la si può addirittura scoprire ben oltre la fatidica linea d’ombra degli anta), allinea una serie di personaggi e situazioni il cui intreccio, pur nello sviluppo narrativo non proprio canonico, partecipa molto da vicino di quello della commedia. Paréven furmìghi riesce addirittura a strappare la risata, soprattutto a chi percepisce le sfumature del dialetto cavriaghino, come nell’irresistibile momento dell’enunciazione degli scotmai del paese, i soprannomi con cui ciascuno è davvero conosciuto e con i quali a ciascuno ci si rivolge. Ma anche Partitura per volti e voci, Diritto di cittadinanza (1996), persino l’estremo Come prima più di prima t’amerò (1995) rientrano in quest’ottica di comédie humaine balzachiana che, con una curiosità insaziabile al di là di ogni ipotesi progettuale, sta dietro un po’ a tutto il cinema del regista torinese.
Scrivere di Daniele Segre rischia di essere sempre un esercizio scomodo se non pericoloso. Con quel rigore implacabile, il suo cinema richiede infatti ogni volta allo spettatore — e a maggior ragione al critico — uno sforzo di adesione e di scavo in profondità che assume le caratteristiche dell’autoanalisi, della messa a nudo. Fonte di emozioni profonde che hanno talvolta come corollario il disagio, si colloca aristocraticamente in una soglia-cerniera con i territori di un altro da sé che ciascuno di noi tenderebbe ad esorcizzare — che la quasi totalità della produzione corrente di fatto esorcizza — insinuandosi tra le pieghe di un “sociale” perturbante e come tale rimosso. Cinema di testimonianza, parte dall’analisi di un reale spesso scomodo e ne reinventa le coordinate fissandolo in un elevatissimo grado di stilizzazione. Gesto di compro-missione anche linguistica, evita le secche delle convenzioni drammaturgiche realizzando un equilibrio fra ragioni storiche, contingenti, e dimensione archetipica ed immutabile, sia essa tragica o “di commedia”. Quanto alla natura del suo lavoro, all’eterna, scontata, irritante e in fondo inutile necessità classificatoria (la fiction, il documentario e le loro possibili combinazioni), crediamo valga ancor oggi quanto, ormai parecchi anni fa, ha scritto Alberto Barbera a proposito del metodo Segre: «Consiste… in un passaggio continuo e quasi impercettibile di campo:dal documentario alla fiction, e viceversa. Assunti non già come momenti successivi per quanto interagenti, ma precisamente come istanze discorsive simultanee, scivolamenti progressivi da un piano all’altro, all’interno della medesima sequenza, della medesima inquadratura. Si tratta insomma per Segre di complicare in continuazione l’evidenza del documento con lo spessore della rappresentazione, senza peraltro mai sovrapporre artificialmente la messa in scena alla naturalità reale». In questa pratica, coerente nella sua continua evoluzione, il regista è diventato immediatamente riconoscibile nel panorama cinematografico — e non solo, beninteso, in quello nazionale — con la caratteristica che è propria solo degli autori di razza: l’unicità.