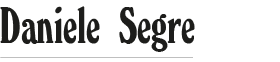Antonio Medici/host.uniroma3.it
Estratto da Elettroshock. 30 anni di video in Italia 1971-2001,
a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 49-54.
La mediazione più corta.
Appunti sul video documentario italiano
Antonio Medici*
Una volta si chiamava documentario, oggi si definisce non-fiction.
L’avvicendamento dovrebbe liquidare un presunto privilegio d’opposizione
al cinema di finzione, che il documentario avrebbe in quanto cinema della realtà.
I campi avversi sono fiction e non-fiction, dove spetta a codici e forme determinare
un diverso rapporto con il reale. «Si può addirittura dire che nella non-fiction
il problema della “manipolazione”, della formalizzazione, è più incombente
e più sentito che nella fiction» 1.
Insomma, i flussi audiovisivi debordano da tradizionali e malcerti argini e il paesaggio
assume una nuova topografia 2.
Resiste il fortino (commerciale e culturale) del lungometraggio
di finzione, mentre si stende tutt’intorno il territorio policentrico e sconfinato di
ciò che non gli assomiglia, di ciò che è altro. In questo territorio vive oggi il documentario,
attratto, mi pare, dalle molteplici possibilità di ridefinirsi, di sperimentare e di contaminarsi
che il frangente offre. Anche perché, sotto i vecchi e comodi distinguo hanno sempre covato
tensioni esplosive, che hanno portato nella finzione l’istanza documentaria e viceversa.
La cinematografia italiana, benché non le sia riconosciuta né una grande scuola documentaristica
né autori di fama internazionale, non ha certo lasciato sguarnito il versante
documentario, caratterizzato da un ventaglio di esperienze assai ricche e articolate 3,
tutte da indagare. Il problema è su un altro versante: le opere non hanno distribuzione,
non arrivano in sala o sul piccolo schermo.
Così il documentario resta ancora oggi una grande terra sommersa, che, tra l’altro,
la scarsa propensione degli studi cinematografici ad occuparsene
non aiuta certo ad emergere. La sua circolazione era difficile anche quando il cinema italiano
navigava a vele spiegate (penso alla ricca produzione documentaristica degli anni Cinquanta
e Sessanta, spesso di cortometraggio), per cui si capisce che, al sopraggiungere della
crisi degli ultimi decenni, le previsioni erano per il peggio. In particolare, il moltiplicarsi delle
televisioni alla fine degli anni Settanta sembrava mettere in discussione lo statuto stesso
dell’idea documentaria, legata tradizionalmente a un compito d’indagine e restituzione della
realtà che il mezzo televisivo, con la sua velocità, avrebbe reso inattuale.
Per fortuna, le cose sono andate altrimenti. Il video (dal videotape, come veniva chiamato
negli anni Settanta, al digitale degli ultimi anni) ha rappresentato un elemento di controtendenza,
che, insieme ad altri fattori (ad esempio, i tanti festival che hanno aperto una
possibilità di circuitazione delle opere), ha dato al documentario chances di sopravvivenza.
La nuova tecnologia elettronica ha consentito l’abbattimento dei costi e una maggiore facilità
e versatilità d’impiego, e ha trovato cineasti pronti ad impadronirsene. Il terreno era stato
a lungo preparato dalla teoria e dall’opera di Cesare Zavattini, fautore di un cinema libero
e alla portata di tutti, sganciato dai condizionamenti degli apparati tecnologici e produttivi
dell’industria. Molti giovani si erano già misurati con forme di utilizzo libere e innovative
del cinema a passo ridotto, come ne Il cinegiornale della pace (1962) e, soprattutto, nei Cinegiornali
liberi (1968-’71), iniziative tutte promosse da Zavattini. Grande, dunque,
l’entusiasmo suscitato dal video, che in Italia comincia ad essere utilizzato a partire dal
1972, soprattutto negli ambienti del cinema militante e underground. Roberto Faenza, in
Senza chiedere permesso (Feltrinelli, 1975), preconizzava addirittura l’avvento dei “videoteppisti”
(gioco di parole con il termine videotape), avanguardia di un futuro più democratico della
comunicazione audiovisiva. Ma tale aspirazione rimane un nodo teorico/pratico largamente
irrisolto. Il bilancio delle esperienze tentate è insoddisfacente, ed è lo stesso Zavattini a
darne una lettura: «Quante volte si era detto che il giorno che la macchina da presa sarebbe
stata nelle mani di tutti, quello avrebbe potuto essere “giorno di rivoluzione”: nel senso di
un cinema di avanguardia morale innanzitutto, contributo specifico a una cultura di azione.
… E’ accaduto quasi l’opposto … Milioni di individui che posseggono una macchina da
presa risultano degli integrati ante litteram, e non hanno intenzione di approfittare di essere
fuori dalla costrizione, dalla corruzione, dai soffitti bassi del meccanismo del cinema maggiore
» 4.
In realtà, la tecnologia video non aboliva neanche la persistenza di funzioni specialistiche
e di notevoli investimenti tecnici. Armando Ceste ricorda come il CCM (Collettivo
Cinema Militante) di Torino «all’inizio del 1973, si dotò di una videocamera portatile, Shibaden
1/2 pollice (Video Tape Recording), una delle prime che si vedevano in Italia, che registrava,
non su cassetta ma su nastro, le immagini in bianco e nero. […] Si potevano registrare
immagini e suoni contemporaneamente, il “girato” si poteva vedere immediatamente,
con le stesse persone, studenti, operai, che poche ore prima avevamo ripreso mentre
sfilavano in una manifestazione o stavano occupando una fabbrica. Non avendo però a disposizione
nessuna struttura di post-produzione, pochissimo di questo materiale è stato montato» [corsivo
mio] 5.
Il video consente però prove fondamentali di sperimentazione politica/
etico/linguistica: citiamo per tutte il lavoro di Alberto Grifi che, insieme a Massimo
Sarchielli, registra nel 1972, su nastro da ¼ di pollice, undici ore di materiale su/con una
ragazza minorenne, incinta, che fa uso di anfetamine. Da questo materiale nasce il film Anna
(220’), trasferito su pellicola 16 mm con un vidigrafo costruito da Grifi stesso, e presentato
nel 1975 ai festival di Berlino, Cannes e Venezia (oltre che in rassegne minori). Si tratta
di un’opera che fa saltare ogni preventiva grammatica produttiva e linguistica: il film si fa
con ciò che accade davanti o intorno all’obbiettivo, a cui non si sottrae nessuno, compresa
la troupe, le attrezzature, o chi crede di essere “fuori campo” (come ad esempio un commissario
di polizia). Ciò che accade coinvolge tutti, dato che tutti in qualche modo entrano
in rapporto, al di là dei propri ruoli, con Anna, in grado di attrarre l’attenzione con una sorta
di forza “sciamanica”. Il film di Grifi è un’esperienza che inaugura, per il video, quel territorio
di confine dove sono difficili le classificazioni, e perciò tanto più produttivo per la
riflessione sull’uso del nuovo mezzo e sulle sue potenzialità.
Tra l’altro, con l’idea di realizzare produzioni televisive di base, si formano molti
gruppi spontanei, legati a realtà territoriali o universitarie. Hanno come obiettivo l’indagine
sul territorio o nelle fabbriche con il diretto coinvolgimento dei soggetti interessati: ricordiamo,
fra le tante esperienze, quella di Bologna (Roberto Faenza, Giuseppe Richeri ed altri)
e quella del Valdarno (Ivano Cipriani, Stefania Brai e compagni). Da ricordare anche
alcune opere di Silvano Agosti che, dopo aver realizzato un lavoro di documentazione sulla
malattia mentale a Parma, con Matti da slegare (1974) – realizzato insieme a Bellocchio, Rulli
e Petraglia – torna ad indagare la stessa realtà con i video D’amore si vive (1983) e Bell’amore
(1986), ritratti partecipi ed essenziali di uomini, donne e bambini che raccontano le loro
particolari esperienze amorose.
Estratto da Elettroshock. 30 anni di video in Italia 1971-2001,
a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 49-54.
3
I fermenti, come si vede, non mancavano, tanto da attendersi che il video potesse
generare una tensione esplorativa maggiore. Eppure, a voltarsi indietro, per gettare uno
sguardo, sia pure sommario, agli ultimi due decenni 6, bisogna riconoscere che il documentario
molto lentamente si è avventurato nella sperimentazione, quantomeno per saggiare
possibilità e limiti del mezzo. Certo, il contesto italiano non si è dimostrato tra i più favorevoli,
e molto di ciò che è stato fatto si deve al lavoro “sotterraneo”, personale ed eroico di
autori (e produttori) giovani e meno giovani, un lavoro che oggi, per molti versi, viene finalmente
riconosciuto. Per queste vie, spesso tortuose, il documentario ha trovato modo di
continuare ad esistere, quantunque dimenticato dalle leggi sul cinema, omesso dalla televisione
pubblica e privata, mortificato da un’industria culturale senza vitalità.
Penso, anzitutto, ad un autore come Daniele Segre, il cui itinerario è per molti aspetti
paradigmatico: per la scelta dell’indipendenza produttiva (nel 1988 ha fondato la Cammelli
Factory); per il rapporto con le sedi regionali della Rai (con cui ha lavorato nei primi anni
Ottanta); per il rapporto con gli enti locali e con le realtà organizzate (sindacato, associazioni,
festival, fondazioni etc.), che hanno ricoperto il ruolo di committenti/finanziatori in
assenza di investimenti produttivi pubblici e privati; per i temi, inerenti quegli aspetti della
realtà del paese che non passavano e non passano né in televisione né nella fiction: le vite
messe ai margini da una società opulenta e distratta, l’attenzione alla memoria collettiva.
Le opere testimoniano – nel variare dei contesti produttivi – un personale rigore di
stile: dopo le prime “ruvide” prove di documentazione sociale 7, Segre mantiene una costante
attenzione sui territori dell’esclusione, da Ritratto di un piccolo spacciatore (1982) a Tempo
di riposo (1991), biografia per immagini di un vecchio attore “fallito”, da cui nascerà il lungometraggio
di finzione Manila Paloma Blanca (1992), da Sto lavorando (1998), sull’esperienza
di integrazione-lavoro di un ragazzo psicotico grave alla Cittadella di Assisi, fino al film A
proposito di sentimenti (1999), racconto della quotidianità, dei sogni e dei sentimenti di quindici
giovani con Sindrome di Down. La memoria operaia si fa voce e volto – attraverso una
severa depurazione formale – in Partitura per volti e voci. Viaggio tra i delegati CGIL (1991) e
Protagonisti. I diritti del ‘900, (2000), entrambi prodotti dalla Cgil. Infine, caso unico in Italia,
Segre ha dato vita, dal 1989 al 1997 alla Scuola di documentazione sociale I Cammelli, i cui
allievi hanno collaborato alla realizzazione di Crotone, Italia (1993), sulla rivolta degli operai
dell’Enichem, e Dinamite (1994), sullo sciopero dei minatori della CarboSulcis.
Se la scelta del video, nella maggior parte dei casi, è determinata da fattori produttivi
(il costo, la velocità di realizzazione, la committenza televisiva), più che da un consapevole
lavoro sulla differenza dei formati, sembra che nell’ultimo decennio il panorama documentario
italiano mostri maggiori fermenti di consapevolezza, di impegno conoscitivo e di libertà
creativa. Di fatto, «nella ormai lunga vacanza configurata dal lungometraggio italiano», il documentario
ha costituito, come scrive Gualtiero De Santi, «un archivio materiale e morale
non altrimenti surrogabile» 8 sulla storia e le storie di questo paese altrimenti invisibili. Dal
variegato ventaglio dei prodotti più recenti, emergono alcune indicazioni di stile che si saldano
all’uso del video: una vicinanza di sguardo, una maggiore intimità con storie di uomini
comuni che si lasciano raccontare e rappresentare con grande naturalezza. Lo strumento
è leggero e poco ingombrante (quasi invisibile, se si pensa alle piccole videocamere digitali),
e l’autore che voglia porsi in contatto con una confidenza testimoniale intensa e vera, che
mette in gioco il proprio ruolo nel raccoglierla, forse trova nel video – parafrasando Zavattini
– una mediazione ancora più corta (la questione, comunque, richiama un nodo etico/
estetico fondamentale per il documentario). La parola è diversamente protagonista, sia
quando è racconto di memoria e testimonianza, sia quando è presa diretta sulla realtà. Non
più voce over, che argomenta, spiega e dimostra riducendo le immagini a illustrazioni, ma
fatto materico-espressivo, legato ai volti, alle emozioni.
Estratto da Elettroshock. 30 anni di video in Italia 1971-2001,
a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 49-54.
4
Per fare qualche esempio, senza pretendere l’esaustività, ricordo Do You Remember
Revolution? (1997), di Loredana Bianconi, asciutto, essenziale, rigoroso ritratto di quattro
donne che raccontano la loro esperienza della lotta armata: Adriana Faranda, Nadia Mantovani,
Susanna Ronconi, Barbara Balzerani; Nella prospettiva della chiusura lampo (1997), di
Paolo Pisanelli, che restituisce la parola incerta, sconnessa, ma a volte lucidissima, dei malati
di mente di Santa Maria della Pietà di Roma, componendone un’amorosa galleria di ritratti;
Uomini e lupi (1997), di Daniele Vicari, racconto di emozioni, sogni e rabbia dei pastori
macedoni che sul Gran Sasso, in condizioni di terribile isolamento, accompagnano al pascolo
le greggi italiane; Prove di Stato (1999), di Leonardo Di Costanzo, “pedinamento” del
sindaco di Ercolano, Luisa Bossa, che si confronta, litiga e combatte con i suoi stessi cittadini
elettori, abituati a rapportarsi con l’istituzione solo attraverso il meccanismo clientelare;
Intervista a mia madre (2000) di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, vite di adolescenti
napoletani sfrontati e smaliziati, che si mettono in scena, quasi senza pudore, dinanzi
all’occhio della videocamera.
La voce over, se c’è, stabilisce con le immagini rapporti più liberi (ma alla Rai si continuano
a produrre e a mandare in onda film a base di repertorio con il classico speaker incolore).
Nell’uso del commento è forte la soggettività autoriale: mi vengono in mente film
come Le ceneri di Pasolini (1994), di Pasquale Misuraca, “documentario di poesia” con materiali
d’archivio cinetelevisivi, personalissima rievocazione della vita e dell’opera
dell’intellettuale; come Ce ne ricorderemo di questo pianeta. Un sogno di Sciascia in Sicilia, (1999) di
Salvo Cuccia, sulla vicenda umana e culturale dello scrittore siciliano, in immagini in bianco
e nero e a colori tessute con parole dello stesso Sciascia, oltre che attraverso testimonianze
di Sofri, Caselli, Pannella, Sellerio e altri. Su un altro versante ancora, la musica diventa protagonista
in Materiale resistente (1995) di Guido Chiesa e Davide Ferrario, dove le parole delle
vecchie canzoni partigiane, ri-arrangiate da alcuni gruppi della nuova scena musicale italiana,
costituiscono una sorta di ponte della memoria per un’indagine sull’antifascismo dei
giovani militanti di sinistra.
Il tema della memoria è un nodo centrale nel dibattito culturale degli ultimi anni, legato
a quella sorta di astoricità che viene contrabbandata come l’esito inevitabile della condizione
post-moderna. Il documentario allora propone una resistenza all’oblio, per conservare
le tracce, riesplorarle, fare storia. Si torna a parlare di lotta partigiana, con una sensibilità
anticelebrativa, che privilegia la dimensione dell’uomo, la sua esperienza quotidiana
(come, ad esempio in Partigiani, 1997, di Chiesa, Ferrario, Piccioni, Leotti, Vicari o Bulow,
1999, di Fausto Pullano e Silvia Savorelli, il primo sulla lotta partigiana a Correggio, il secondo
sul comandante partigiano Arrigo Boldrini). Oggi è un altro giorno. Milano 1945-1995
(1995) di Bruno Bigoni e Giuseppe De Santis, si propone nella forma della docu-fiction come
una lezione di storia su alcuni luoghi della resistenza milanese. Più problematica è la memoria
recente, materia ancora ribollente di tensioni: ricordo Nome di battaglia: Bruno (1987),
di Bruno Bigoni, ritratto di un terrorista suicida tra cronaca e fiction; Alla Fiat era così
(1990), di Mimmo Calopresti, colloquiale testimonianza degli operai di Mirafiori, che tentano
un bilancio delle loro lotte nell’Autunno caldo; Aria di golpe (1994) di Armando Ceste, in
cui Dario Fo e Franca Rame rivedono e rivivono (attraverso immagini in bianco e nero riprese
con uno dei primi videotape) tutte le emozioni dello spettacolo Guerra di popolo in Cile,
messo in scena il 27 ottobre 1973 al Palazzetto dello Sport di Torino. Un cenno particolare
andrebbe riservato al lavoro straordinario di Paolo Isaja e Maria Pia Meandri, che fanno
della memoria uno dei centri propulsivi della loro cooperativa Cinema Ricerca. Ricordo, a
titolo di esempio: Storie della malaria sul litorale romano alla fine dell’Ottocento (1994), Jolanda e
Rossellini. Memorie indiscrete (1996), Tornare a Orgosolo (1997), Gramsci, la forma della memoria
(1998). Film in cui si depositano le tracce di tradizioni che vanno scomparendo, residui di
una cultura popolare e contadina in via di cancellazione, come, per fare un altro esempio,
Estratto da Elettroshock. 30 anni di video in Italia 1971-2001,
a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 49-54.
5
in La scatola del vento (1999), di Paolo Di Nicola, in cui rivivono ritmi e suoni d’organetto,
strumento tipico della tradizione contadina.
Nei video-ritratti si lasciano tracce di vita attraverso quella “morte al lavoro” che sono
le immagini in movimento: tra i tanti, Angelo Novi fotografo di scena (1992), di Antonietta
De Lillo, che viaggia nella storia del cinema dietro le quinte, attraverso le foto di Novi sui
set di Rossellini, Pasolini, Bertolucci e altri; L’amore vincitore. Conversazione con Derek Jarman
(1994), di Roberto Nanni, che utilizza pellicola 16 mm, super 8 e super VHS, per un ritratto
del cineasta inglese, già ammalato, che proprio la commistione dei supporti carica di
drammaticità e di inquietudine; Ogni sedia ha il suo rumore (1995), di Antonietta De Lillo, ritratto
della poetessa Alda Merini, montata con brani del monologo Deliro amoroso recitati da
Licia Maglietta; Enzo, domani a Palermo! (1999), di Ciprì e Maresco, omaggio affettuoso a
Enzo Castagna, il “re delle comparse”, instancabile supporto a tutti quei cineasti che hanno
girato in Sicilia (Visconti, Coppola, Pasolini, etc.), agli arresti domiciliari per aver preso parte
a una rapina.
L’altra Italia, quella che non vedremo passare mai sugli schermi televisivi se non in
forma di cronaca patologica, è un altro grande distretto del film di documentazione.
Nell’insieme, benché si tratti di una produzione molto eterogenea, si fa avanti un quadro
antropologico del Belpaese, attento alle storie degli uomini piccoli, alle zone d’ombra, ai
percorsi tangenziali. Sotto il segno dell’anti-ufficialità nasce Italia Novanta: lavori in corso
(1990), opera collettiva che vuol mostrare quello non mostrano i dodici documentari ufficiali
sull’Italia dei Mondiali, affidati dal Luce a noti cineasti; lo stesso paesaggio di cantieri
inutili, di velleità alla grandeur, lo ritroviamo alla fine del decennio in Roma A.D. 1999
(1999), di Pisanelli, gustoso ritratto della capitale mentre si prepara il Giubileo. Ma certi elementi
di degrado umano e civile del paese si possono leggere tra le righe anche in storie
minime, come nei Promessi sposi (1993) di Antonietta De Lillo, vita di un transessuale e del
suo compagno nella periferia napoletana; nei Femminielli (1994) di Michele Buono, Carmine
Fornari e Pietro Riccardi; nelle Angelesse (1994), di Roberta Torre, che ritrae sette donne palermitane
dei quartieri Zen e Borgo Nuovo; in Shqiperia (1997) del gruppo romano dei
Fluid Video Crew, racconto in sei capitoli sul dramma degli Albanesi sbarcati a Brindisi; in
Pomodori (1999), di Gianfranco Pannone, che risale la penisola da Sud a Nord attraverso
piccole storie legate alla lavorazione dei pomodori; in Rom Tour (1999), di Silvio Soldini e
Giorgio Garini, con Antonio Tabucchi che ci guida nell’inferno dei campi nomadi di Firenze.
Non sono mancati anche gli sguardi lanciati con intelligenza e partecipazione oltre il
perimetro della realtà nazionale: ricordiamo Il mio triste continente (1985) di Annalisa Scafi e
Roberta Mazzoni, testimonianza di una ragazza cilena sopravvissuta alla tortura; Sahrawi,
voci distanti dal mare (1997), di Antonietta De Lillo, Jacopo Quadri, Patrizio Esposito, viaggio
alla scoperta della comunità Sahrawi, minoranza combattente per la propria identità, costretta
dal Marocco a vivere nei campi profughi del deserto algerino; Danzando in Cambogia
(1998) di Italo Spinelli, rievocazione, attraverso la vita di una danzatrice, della drammatica
storia di un paese; L’iniziazione (1999), di Ilaria Freccia, sulla lotta alla pratica
dell’infibulazione tuttora presente e diffusa nel continente africano e nelle comunità immigrate
in Europa.
Con il video si sono misurati anche documentaristi di lunga esperienza. Ansano
Giannarelli ricostruisce in Memoria presente (1984) la persecuzione antisemita a Roma, durante
l’occupazione nazista, con testimonianze di cittadini ebrei e non; Gianni Amico realizza
un Diario di Manarola (1987) in cui fa convergere in video alcuni super 8 privati e gli appunti
per un progetto di film su Telemaco Signorini in Liguria. Luigi Faccini realizza due intensi
lavori sui territori dell’esclusione sociale con Villa Glori (1988), e Casal del Marmo (1990).
Estratto da Elettroshock. 30 anni di video in Italia 1971-2001,
a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 49-54.
6
Molti dei nomi ricordati in questa veloce carrellata (ma tanti altri, per limiti di spazio,
ho dovuto tralasciarli), hanno praticato insieme, spesso incrociando i percorsi, documentario
e film di finzione: Agosti, Chiesa, Ciprì e Maresco, Calopresti, Faccini, Ferrario, Giannarelli,
Soldini, Torre, ecc.. A questi possiamo aggiungere i nomi di Gianni Amelio, Francesca
Archibugi, Mario Martone. Spesso il documentario ha rappresentato un territorio più
libero di sperimentazione e di conoscenza, contiguo ai temi, ai paesaggi, alle storie narrate
nella fiction. Talvolta, si è registrato un rapporto ancora più stretto, in cui il video ha funzionato
come taccuino di appunti e suggestioni visive per un film da fare: come in n. 0576 –
Appunti per un documentario su Pozzuoli (1988), di Giuseppe Gaudino, che raccoglie materiali
per la lunga gestazione di uno dei film più belli e stimolanti dell’ultimo decennio, Giro di
lune tra terra e mare (1998); come in Appunti per un film su Tano (1995), di Roberta Torre, che
prelude a Tano da morire.
Ma forse non è un caso che tra i nomi sopra ricordati ci siano gli autori più interessanti
del cinema italiano degli ultimi decenni.
NOTE
1 Adriano Aprà, Ai confini della realtà: uno schema di guida, in Le avventure della nonfiction, catalogo della XVI
rassegna retrospettiva della Mostra internazionale del Nuovo cinema, Pesaro, 25-30 novembre 1997, p.
9.
2 «L’effetto più importante e più significativo indotto dalla televisione nel linguaggio dell’immagine-inmovimento
(motion picture) è stato proprio quello di ricordarci in quanti modi, per quali tipi di discorso
può essere usata l’immagine audiovisiva: appunto, saggio, inchiesta, messaggio pubblicitario, composizione
audiovisiva di tipo poetico, fiction di durata breve (one-reel movie), videoart». Carlo Lizzani, Il discorso
delle immagini, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 48-49.
3 I nomi da fare sarebbero tanti: Amico, Antonioni, Baldi, Bellocchio, Bertolucci, Bizzarri, De Seta, Di
Gianni, Emmer, Ferrara, Gandin, Giannarelli, Lizzani, Maselli, Mingozzi, Nelli, Orsini, Pasolini, Pontecorvo,
i Taviani, Vancini e molti altri.
4 Cesare Zavattini, Neorealismo etc, a cura di Mino Argentieri, Milano, Bompiani, 1979, p. 281.
5 Armando Ceste, I picchetti e le cineprese, in Filmare il lavoro, a cura di Antonio Medici, Annali della Fondazione
Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, III, Roma, 2000, p. 139.
6 Ecco alcuni riferimenti bibliografici: Giampaolo Bernagozzi, Il cinema corto. Il documentario nella vita italiana
dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, Firenze, La Casa Usher, 1979; Roberto Nepoti, Storia del documentario,
Bologna, Patron, 1988; Sindacato Nazionale Critici Cinematografici (a cura di), Libro bianco. Il
documentario in Italia: sopralluoghi, Festival dei Popoli, Firenze, 1994; A proposito del cinema documentario,
Annali della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, I, Roma, 1998;
Marco Bertozzi, L’idea documentaria. Alla ricerca di una identità italiana, in Il cinema della transizione, a cura di
Vito Zagarrio, Venezia, Marsilio, 2000.
7 Mi riferisco a Il potere deve essere bianconero (1978, 16mm, b/n, 13’) e Ragazzi di stadio (1980, 16mm, colore,
60’). Sulla base di queste esperienze, Segre allestì una mostra fotografica, esposta in una sezione
del Festival nazionale dell’Unità di Genova (1980), con il titolo Forme ed espressioni della cultura operaia.
Ne seguirono alcune polemiche sulla scelta di attribuire alla cultura operaia la presenza di questi “ragazzi
di stadio”.
8 Gualtiero De Santi, Ultime stagioni, catalogo della V Rassegna del documentario italiano. Premio Libero
Bizzarri, 18/25 luglio 1998, p. 18.