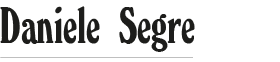Paolo Vecchi – Cineforum n.322
Già il prologo – un tram che quasi sbanda nella città, lo scherno quotidiano al protagonista, la sua reazione, affidata all’incomprensibilità di una formula deprecatoria e alla forza esorcizzante di un ghigno che costituirà il trait d’union simbolico della vicenda – è di quelli che lasciano il segno, avvisaglia ineludibile di tonalità “alte”. Poi, dopo le campane elettroniche sullo schermo nero dei titoli di testa, ecco l’incubo, “sgranato” nel misterioso livore del video, allucinazione ma anche coscienza di sé, spesso mediata dalla scrittura scenica: ossessione carnale, della gelosia, in Büchner, invettiva biblica in Shakespeare, metalinguaggio “professionale” in Pinter. Infine, più impressionante, il silenzio, contemplazione di sé «en abime», sospensione temporale di sconvolgente intensità tragica, che fa pendant con i lunghi, strazianti primi piani allo specchio. Tutto il film ha questo andamento schizoide, decisamente riassunto da una battuta del protagonista: «Lui era stato in manicomio… poveretto! Non sapeva a chi parlava». Segre scrive di un personaggio che ha staccato la spina di contatto con la realtà, di una sensibilità che lo porta a subire le violenze di un mondo che vive con altre regole e ritmi. Il film gli costruisce intorno con incisiva rapidità di connotazioni tre ambiti diversi. Innanzitutto quello dell’emarginazione (Porta Pazzo livida di mattino, la stanza angusta che Carlo divide con Guido, il refettorio gestito da religiosi, i corridoi dell’USL, l’Hotel Italia vicino alla stazione), con il suo brulicare di esistenze maleodoranti e borse di plastica stipate di stracci. C’è poi quello del teatro, assunto in una veste duplice. Come ricordo, talvolta commosso e commovente nella sua canagliesca ingenuità (l’aneddoto vero dei programmi del «Piccolo» venduti a prezzo doppio), talaltra sprezzante nella coscienza di chi non si è piegato alle “regole” (i due ex compagni di corso che hanno avuto successo, appaiono in televisione, «ma sono due teste di cazzo, non valgono due lire»). Come obiettivo attuale e ossessionante, tappa obbligata per il “rientro” in una più vasta accezione di normalità (in questo tentativo, Carlo da un lato è deluso dall’atteggiamento sfuggente del regista omosessuale, dall’altro è riconfermato nelle sue convinzioni dalla squallida “oggettività” della prova rissosa con i due attori). Infine, il milieu ebraico torinese. E in tutta evidenza quello che più interessa al regista, disposto a spendersi nel personaggio di Sara Treves ben oltre i limiti degli altri, semplici presenze funzionali al “caso Carlo”. Con un rilevante investimento autobiografico, Segre carica di domande l’anomalo rapporto fra i due, senza sciogliere mai l’ambiguità che lo caratterizza. L’appartenenza, sia pure problematica, di Sara («Ma tu sei religiosa?» le domanda Carlo. «La mia famiglia. Io… non so» risponde la donna) si inscrive infatti nell’ambito della contraddittorietà. Membro di una comunità etnica che la storia ha caratterizzato come marginale, la donna è attratta da Carlo per una “curiosità” in cui gioca probabilmente anche il suo status di intellettuale, che le suggerisce sia un interesse “conoscitivo”, sia una più generica pietas. Il rapporto con questo «extraterrestre con un’oliva in mano» finisce fatalmente per essere anche ricerca di sé, della propria “diversità”: così, il film diventa la più lucida e toccante incursione nella cultura dell’ebraismo che mai ci abbia consegnato il cinema italiano, aprendoci le porte della sinagoga in una Torino mediorientale («Gerusalemme… laggiù, la vedi? C’è la porta di Damasco», scherza Carlo), reinventata con angolazioni che ce la raccontano come città straniera” e multiforme, quale appare agli osservatori meno distratti. Ma l’ambiente ebraico può anche funzionare in direzione opposta, come bozzolo rassicurante in cui rientrare tornando a sposarne le rigide convenzioni. Non è un caso che le avvisaglie della separazione fra il protagonista e la sua compagna maturino durante la celebrazione di un rito familiare. In una sequenza pregnante, giocata su un attentissimo montaggio alternato, Sara partecipa con i congiunti ad una cerimonia officiata dal padre, mentre Carlo, rimasto solo, mette in scena altri rituali, suggeritigli dalla propria mente disturbata. Il rientro in famiglia sembra significare per la donna il recupero della norma, tanto che il distacco si consuma quasi immediatamente. Carlo viene risospinto in pieno magma, con la sola prospettiva illusoria di un altrove, in Polonia o in Africa, a vivere l’indivisibilità fra maschera e volto, testimonianza estrema di un’umanità esorcizzata e imprescindibile, specchio in cui la gente si rilette e di cui per questo ha paura. E Carlo Colnaghi a ricordarcelo ancora una volta, guardando in macchina, con un’impressionante antirecitazione epica che commuove per disarmata “confusione” e sconvolge per risentita auto coscienza: «Voi lo sapete bene dove finisce il palcoscenico… Credete che basti una ribalta per fare il palcoscenico… Io sono stato per le strade, sono stato in America, ho visto cose che voi leggete solo sui libri. Ho visto la povera gente recitare una parte senza sapere chi l’aveva scritta per loro. Miserabili, gente in catene, fame. L’ho visto e questo mi ha fatto scappare. Mai più una cosa del genere».
Autore critica: Paolo Vecchi
Fonte critica: Cineforum n. 322
Data critica:
3/1993