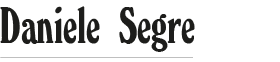Lietta Tornabuoni / La Stampa
Daniele Segre, quarantenne, regista capace di guardare la miseria del mondo senza sadismo né distacco, aveva dedicato all'ex attore malato di nervi Carlo Colnaghi un bellissimo videoritratto intitolato «Tempo di riposo»: in questo film, il cui titolo è appena un suono, un accostamento speranzoso e disperato di sillabe esotiche, l'uomo del ritratto acquista una dimensione narrativa e un nome da personaggio (Carlo Carbone), vive una storia immaginata con principio svolgimento e fine, si recita un'altra vita possibile e si conferma un attore molto bravo.
Sono difficili da dimenticare le peregrinazioni per Torino della sua esistenza solitaria, raminga e accattona, i pasti consumati per la carità delle suore, le stanze di pensioni desolate pagate dalla Usl, le bugie d'un viaggio raccontate per scroccare soldi agli amici d'un tempo, le furie repentine nel sentirsi osservato con malevolenza e gli assalti dell'autodisprezzo, i mulinelli del Po e la luce dell'alba (la direzione di fotografia, ammirevole, è di Luca Bigazzi), le lettere-confessione («Mi sento a disagio, vuoto, nullo, sempre più solo»), l'alcol, il Valium, il Disipal, la tosse squassante, le risate terribili, le precarie immersioni nel mondo di prima. Per caso l'ex attore reduce dall'ospedale psichiatrico incontra una giovane donna ricca che (per curiosità, per compassione, per capriccio, per senso d'onnipotenza) lo aiuta, mostra di volergli bene, lo induce a lavorare a un testo teatrale, Io ospita, diventa l'unica sua sicurezza. Ma è un'illusione breve: il timore d'essere abbandonato rende l'uomo aggressivo e prepotente, lei lo allontana e lui torna alla sua vita sola, errante. Fanno da contrappunto alla storia citazioni video in bianco e nero di esibizioni teatrali dell'attore, incursioni nell'ambiente della borghesia ebraica torinese (una visita alla sinagoga, una ricorrenza religiosa festeggiata in famiglia). Il film arriva a comunicare molto bene, con pathos intelligente e delicatezza, il dramma d'un uomo la cui follia sta soltanto in una impossibilità di accettare la volgarità del mondo e se stesso, in un'ipersensibilità sempre ferita, scoperta, autodistruttiva.