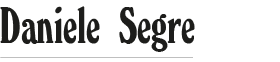Gianni Olla
Dal libro “Daniele Segre – Il cinema con la realtà” a cura di Antioco Floris
Editrice CUEC
Come probabilmente è accaduto ad altri spettatori o critici o studiosi, il mio incontro con il cinema di Segre (e con Segre medesimo) è avvenuto attraverso Vite di ballatoio. Si può qui ricordare che la distribuzione del film era curata dalla società Indigena, alla quale facevano capo altri emergenti degli anni Ottanta: Soldini, Bigoni, Soldi, Rosa. E dunque la circolazione fu soprattutto un’occasione per organizzare, in diverse località italiane, delle piccole rassegne alle quali parteciparono anche i registi di quello che sembrava un possibile ricambio del cinema italiano. Oggi è retrospettivamente difficile separare il film e il contesto nel quale è avvenuto l’incontro con il regista da una serie di referenti politico-culturali legati ad un frammento epocale. Soprattutto ad un dato memoriale che talvolta appare rimosso: i registi di Indigena, con i loro film piccoli e a basso costo, apparivano come la voce o, per usare un termine resistenziale fuori moda, “il vento del nord” contrapposto alla marcescente romanità del cosiddetto grande cinema. Purtroppo, alla prova dei fatti, la maggior parte di quei film erano, non dico viziati, ma quantomeno segnati dalle stesse contraddizioni del cinema “romano” più velleitario. Per dirla tutta apparivano ancora prove, dove il talento (dimostrato, peraltro, anni dopo da un Soldini) era mescolato alla presunzione di poter schiantare d’un colpo — come nei gloriosi anni Sessanta — la tradizionale macchina cinematografica. Potrei anche aggiungere che, in quel panorama non esaltante, il film di Segre brillava per la sua vera diversità, per un reale “scarto della norma” curioso e capace d’incidere nei meccanismi dell’ordinaria visione cinetelevisiva, nonché per il rigore di una scelta poco seducente dal punto di vista dello spettacolo ma assolutamente penetrante. Ma non è questo il punto. Il fatto è che quasi tutti gli spettatori presenti agli incontri (compreso chi scrive) chiesero agli autori «che cosa avrebbero fatto da grandi». E questi risposero come da copione: chi un progetto, chi un altro, ma accomunati dall’idea che quel cinema segnato dalla marginalità produttiva doveva necessariamente uscirne per cominciare a confrontarsi con il cinema normale, seppure marcescente. Solo Segre, un po’ indispettito per la domanda, rispose che “da grande” avrebbe continuato a fare quei film, che Vite di ballatoio rappresentava una sua idea di cinema e non una qualsiasi prova sperimentale. Considerando la successiva carriera del regista torinese, si può dire senza ombra di dubbio che aveva ragione lui e torto la pigrizia del pubblico (e del critico). Ovvero, che il caso Vite di ballatoio, pur rimanendo sostanzialmente atipico (come quasi tutto il lavoro di Segre) nel cinema italiano contemporaneo, persino nelle sue aree di maggior innovazione, è un film esemplare, completo, che postula anche poetiche e modelli forse mai percorsi dai nostri cineasti, o per usare un termine che racchiude maggiormente il senso di quel lavoro, dagli operatori di tutta la comunicazione audiovisiva italiana.
Curiosamente e un po’ contraddittoriamente, quel film si colloca, nella filmografia del regista torinese, ad appena un anno di distanza da Testadura, un vero film a soggetto, con Segre che appariva anche protagonista di una storia racchiusa tra le strade e le pareti delle case torinesi, immersa in autorappresentazioni e autorievocazioni di gemiti generazionali, in itinerari scontati tra musicisti e commercianti alternativi, convivenze difficili, voglie di fuggire o di tagliare i ponti con l’amata/odiata città. Un film normale — con tutta l’ambiguità del termine — dopo un percorso di formazione che chiamerei militante, o di servizio: i documentari sugli “ultras”, il carnevale, la salute. Nonché la droga, tappa obbligatoria dell’audiovisivo di servizio. Anche se poi, proprio il film che Segre gira nel 1982, Ritratto di un piccolo spacciatore, annuncia il primo grosso scarto da una norma documentaria consolidata. Difatti, come annuncia il titolo, è soprattutto un ritratto di un essere umano a cui paradossalmente manca un volto. Il che sembrerebbe una negazione legata a motivi di sicurezza per lo spacciatore ma è invece una scelta estetica, od anche etica, che spesso in Segre è un qualcosa abbastanza vicino all’estetica. Per circa 40 minuti la macchina segue non tanto i preparativi — che potrebbero essere il succo, lo shock del film — all’ennesimo “buco” audiovisivo, quanto le storie e la storia del piccolo spacciatore, la sua filosofia esistenziale, gli arredi della casa, il suo delirio sociopolitico neanche tanto fuori dai binari, le canzoni di Guccini cantate per mostrare la lucidità dopo il buco, le invettive contro il mercato della droga, la sua serenità (apparente?), il contrasto tra l’immaginario terroristico, melodrammatico, del pianeta drogati e quella semplicità di modelli visivi autenticamente realisti, e dunque quasi provocatori, visto che sfidano il modo comune di osservare certi fatti. Finché, con un procedimento di sostituzione quasi naturale, anche quel volto negato viene assegnato dagli spettatori a loro osservazioni extracinematografiche.
Per ritornare a questo fondamentale frammento della filmografia di Segre, si potrebbe dire che esistono delle possibili divaricazioni interpretative. Da un lato appare già delineata una poetica e persino alcuni stilemi: il tentativo di cogliere, senza interferenze, l’esteriorità e l’interiorità dei personaggi, qualunque essi siano; una drammaturgia del reale costruita non a tavolino sulla base di schemi precostituiti, ma attraverso il contatto con la realtà, con l’inserimento del regista dentro le diverse comunità. Una tecnica di ripresa quasi invisibile, in ogni caso volutamente nascosta, occultata dal montaggio, cioè da una scelta di frammenti di racconto, di esperienze ai confini tra la documentazione e l’inchiesta sociologica. Non a caso alcuni titoli di questa prima “tranche” della filmografia di Segre sono stati prodotti dalla Rai del Piemonte nell’ambito dei propri programmi regionali. Come dire che il progetto produttivo — o, nel caso in questione, l’utopia produttiva — ha avuto un ruolo fondamentale nel creare un autore non omologabile in alcun modo. Dall’altro, gli stessi titoli, se vengono letti nell’ottica di una drastica separazione tra audiovisivo e cinema — una separazione che è servita magari a far vivere il cinema ma non a sviluppare gli altri discorsi, cioè a formare registi e operatori dell’audiovisivo — finiscono per essere niente di più che l’apprendistato di un futuro cineasta destinato a immergersi nella normalità del cinematografo.
Come conseguenza di questa seconda interpretazione, però, si deve leggere Testadura all’interno di una esigenza di normalizzazione: un cinema narrativo che racconti ambienti e personaggi di larga comunicazione. Non solo dunque la sfida nel riuscire a raccontare una storia — e dunque inventare una trama, scrivere una sceneggiatura, ambientarla, trovare gli interpreti, etc. — ma anche una sorta di cartina di tornasole di una serie di “impasse” generazionali, nei quali Segre ha rischiato di invischiarsi. Naturalmente, i limiti del film si possono individuare anche in termini specificamente di scrittura: in due parole, una sceneggiatura fortemente deficitaria. Se anche fosse, porterebbe alla medesima dimostrazione: una vocazione diversa di Segre, d’altronde dimostrata anche nell’altro film di finzione, Manila Paloma Bianca, che conferma non già l’incapacità di fare film narrativi, ma di farli a partire da modelli tradizionali. Però, ammesso che questa sia una pista interpretativa corretta (per Manila… Segre si è servito di uno sceneggiatore professionista, Davide Ferrario), io credo maggiormente ad un incidente generazionale, legato al clima del cinema italiano e al bisogno di far sentire la propria voce nel panorama asfittico di quegli anni. Per intenderci, la tentazione di una lettura del mondo post sessantottesco o settantasettesco, racchiuso in se stesso, vagante e in fuga e eternamente insoddisfatto — seppure, con un certo narcisismo, Segre si autorappresenti come un giovane che già lavora in campo audiovisivo e non affatto immerso nella crisi generazionale ma seminai stufo delle lamentele degli altri —non è patrimonio del solo Segre, ma una sorta di “cul de sac” entro il quale si sono arenati, per breve o per lungo tempo, anche altri registi. Ribadisco: non è illegittimo, né sconsigliabile partire dal proprio io, da una “tranche de vie”, per scrivere e filmare. Ma, nel caso del cinema italiano di questi ultimi vent’anni, si è rivelato quasi sempre fallimentare, sia per incapacità dei registi, sia perché il vissuto messo in scena non era poi così fondamentale.
Dunque, la vera svolta della filmografia di Segre finisce per essere Vite di ballatoio, e proprio perché riprende i fili interrotti di quel discorso sugli sguardi esterni, sulle rappresentazioni delle varie marginalità e delle varie invisibilità della cronaca quotidiana, schiacciata tra la spettacolarizzazione dell’informazione e il cinema ad alto tasso fantastico.
In un cinema come quello italiano, che ha giustamente venerato il neorealismo, riferirsi a Segre come l’ultimo seguace del zavattinismo più estremo è una tentazione fin troppo facile. E difatti, forse proprio Ritratto di un piccolo spacciatore, con quella sua immediatezza documentativa, con la pratica del pedinamento di un individuo senza volto, è vicino sia ai modelli classici di cinema verità che a Zavattini. Ma il realismo di Segre non sta tutto in questa eredità nobile. C’è nella progettazione, nella poetica e nello stile delle immagini dedicate ai “ragazzi di stadio”, cosi come in quelle dei transessuali di Vite di ballatoio, un cosciente e radicale rivolgimento di alcuni modelli di realismo classico, basato sull’osservazione/ricostruzione del mondo quasi esclusivamente dall’esterno, con i filtri consueti della drammaturgia consolidata da cento anni di cinema.
La ricostruzione (non pedinamento, dunque) di Segre procede invece assieme ai protagonisti e utilizza tutta la drammaturgia naturale dei gruppi di persone che s’incontrano, chiacchierano, progettano slogan per la partita o spettacoli da discoteca, rileggono, assieme al regista,la loro vita quotidiana e finalmente la reinterpretano. Il punto di partenza è un cinema senza macchina da presa, o come scrive polemicamente Goffredo Fofi, un “arrivare al cinema per altre strade che non il cinema”. Il punto di arrivo è una sorta di autorappresentazione: i protagonisti come emittenti, più o meno unici, della comunicazione. Posti in grado di esserlo, ovviamente, cioè di ricostruire con una certa autonomia i frammenti di vita che intendono proporre al pubblico. L’autorappresentazione è però un modello di comunicazione e di spettacolo rischioso. è stata, ed è tuttora, la pratica quotidiana e la teoria profonda della cosiddetta Tv verità di questi ultimi dieci anni. Ha mostrato momenti di autentica freschezza ma anche e soprattutto una tremenda ambiguità: un cinismo mediatico che ha fatto leva sulla spettacolarità intrinseca della cronaca nera, anzi nerissima (dai morti ammazzati, alle guerre), su un tasso di esibizionismo da cortile o da condominio, e, nei casi peggiori, sul bisogno di parola, di sfogo, di tutti i “senza parola” di questa società dove l’esibizionismo è contagiante e la solitudine ha spesso come interlocutore unico la Tv. Un lavoro non ruffiano in questo campo necessita, prima di tutto, di scelte etiche (di nuovo un legame profondo con l’estetica) che, senza rinunciare a mostrare il lato invisibile dell’informazione audiovisiva, travalichino il cosiddetto diritto/dovere di cronaca entro il quale esibire il tema lacrimoso di turno, il morto ammazzato, i parenti in lacrime ai quali si chiede se provano dolore. Se poi si passa non già ad un referente informativo già situato entro i confini dell’attualità e dell’urgenza (lo spacciatore, i ragazzi di stadio), ma ad una costruzione filmica che ha una sua drammaturgia ondeggiante tra la cronaca e la finzione, il bisogno di arrivare al cinema partendo da altre cose, diviene forse obbligatorio.
Se si riprende per un momento il confronto Testadura/Vite di ballatoio ci si accorge, anche per affinità culturali con gli ambienti rappresentati, che i percorsi dei protagonisti del primo film sono in qualche modo predeterminati, che la loro rappresentazione è talmente tipica — se non ovvia — da porsi sia come modello drammaturgico generazionale, sia come confessione semiautobiografica. In ogni caso, con un tasso di elaborazione bassissimo che non può che impoverire il film. Al contrario, in Vite di ballatoio, dopo la prima impressione di spontaneità, di vita colta al volo e poco rielaborata, man mano che le immagini, le scene di vita familiare e amicale si susseguono, ci si chiede quali strade abbia cercato il regista per arrivare ad una simile ricostruzione, quale lavoro ci sia stato con i protagonisti per trasformarli in attori, quali strategie abbia messo a punto per evitare una messa in scena piena di trappole melodrammatiche o, all’inverso, puramente documentarie, basate sulla sorpresa e lo scandalo del terna. E, ancora, perché tagliare via del tutto il versante biografico (le storie personali degli attori/personaggi), e quali materiali siano stati sacrificati al montaggio per arrivare ad una simile compattezza, ad un discorso che ha i suoi punti fermi, problematici, non declamati teatralmente, ma recitati in sordina, talvolta persino parodiati come nella scena dei conviventi — lui fortemente mascolinizzato, con i baffi, lei in tenuta da casa, senza parrucca — che pranzano a letto come in certe comiche di Stanlio e 011io.
Si può dire che il tema di Vite di ballatoio — scene di vita quotidiane di una comunità di transessuali che abitano e si prostituiscono nelle vecchie case del centro di Torino — proceda infatti attraverso un meccanismo di oscillazione tra il versante più propriamente ricostruttivo del vissuto quotidiano e delle problematiche continuamente ribadite come centro di ogni discorso (il diventare donna completa attraverso l’intervento chirurgico) e quello dell’immaginario collettivo, della spettacolarizzazione del proprio io che Segre, con grande sensibilità (questa volta da cineasta che parte dal cinema e non viceversa), trasforma negli ingranaggi di trascinamento estetico-simbolico del film, nonché in pezzi di grande suggestione visiva. Il continuo riferirsi al trucco, all’abbigliamento, alla cura delle parrucche, allo scambio di oggetti, viene sovraccaricato da tre momenti chiave, collocati strategicamente all’inizio, al centro e alla fine del film. Il primo — la canzone Malafemmina cantata da una delle protagoniste — è una sorta di introduzione che precede i titoli di testa e sembra avvertire lo spettatore che non siamo solamente di fronte ad un documentario. Dopo i titoli, un input narrativo (il colloquio tra Sara e un altro transessuale al quale chiede di comprare qualcosa), ma il filo si spezza subito e il film si concentra in quelle scene che hanno per protagonisti i singoli gruppi, senza alcuna consequenzialità nel montaggio. L’autorappresentazione dei diversi gruppi, delle coppie, delle amicizie, basta a scatenare ipotesi di racconto, biografie, sentimenti, drammi. Quindi un’altra interruzione, con la medesima protagonista del prologo: il monologo tratto da Filumena Marturano. Improvviso, con quel finale quasi esibizionistico, lampeggiante sotto le luci dei riflettori che rimandano al trucco pesante dell’attrice. E qui comincia a chiarirsi un’altra pista sotterranea del film: l’esibizionismo, connaturato nelle scelte di vita dei transessuali, che vorrebbe essere arte, spettacolo, auto-rappresentazione puramente teatrale, sensibilità estetica, capacità di vivere la propria vita come una finzione scenica. L’immaginario, ancora una volta. Infine, dopo gli altri frammenti drammaturgici, la festa (che, dice Segre, fu costruita per l’occasione su un suo impulso) e sequenza finale con Io spogliarello sceneggiato sulla canzone di Renato Zero, Mister Uomo, ugualmente costruito appositamente per il film.
Considerando che uno dei pochi nomi che ricorre nelle passioni cinematografiche di Segre è Fassbinder, verrebbe la tentazione di assegnare queste scene ad una indiretta derivazione fassbinderiana. O forse ad una semplice suggestione tematica — ma anche qui Segre chiarisce che il tema fu lo sbocco di una vecchia curiosità da spettatore verso il mondo dei transessuali — visto che il quadro generale di riferimento è decisamente antifassbinderiano, proprio per il rifiuto di qualsiasi avvolgimento barocco e melodrammatico delle vicende esplorate e rimodellate dalla macchina da presa. Se c’è melodramma — accennato comunque proprio dalle esibizioni teatrali messe nel film come degli “a parte” —esso si contrappone, come fosse appunto un tratto spettacolare della vita dei transessuali, a quel bisogno di raccontare la normalità di un gruppo di individui che sommano diverse “marginalità”: l’essere, quasi tutti, immigrati meridionali, transessuali, prostitute. Ed infine, essere ormai — come sottolinea lo stesso Segre — poco attraenti, forse già vecchi, sul viale del tramonto e dunque raggruppati come in un piccolo mondo separato, con i suoi segni di solidarietà, di affetti, di amicizie che appaiono come il lato umano, almodovariano (e senza scandali o provocazioni) del film.
Il segreto di Vite di ballatoio, dunque, non è un segreto: non è neanche un particolare occhio cinematografico di Segre — seppure il monologo di Filumena Marturano e il finale nella discoteca rivelino un sensibilità davvero fassbinderiana, anche in assenza di barocchismi e melodrammi sofferti. è solo il bisogno di uscire da una serie di “impasse” cinematografici dell’epoca, ricordandosi che il proprio percorso di cineasta si era fino ad allora affermato attraverso una decisa mimetizzazione del proprio io dentro le storie degli altri. Da allora Segre non ha mai smesso di raccontare gli altri, teorizzando e praticando un’idea nobilissima, ma anche esteticamente convincente, del cinema e dell’audiovisivo di servizio